Almost Blue
di Lisa
Se
ne sta là, seduta. La penna, il foglio, la scrivania e
l’oscurità facile in cui stare. Persa nell’assenza
dei contorni e degli spazi, con l’unica certezza del suo
respiro.
Si
strappa a fatica da quell’abbraccio muto e incolore, e accende
la luce.
Mio
caro, scrive curvando le o in cerchi perfetti, due vite chiuse
a recintare spazi bianchi, due margini da cui è possibile
cadere nel niente.
Mio.
Prendersi come due capi usati, scovati fra i banchi di un mercatino
di paese, abbagliati dall’acquisto da non vedere il bottone
sul punto di cadere o l’orlo usurato della tasca. Già
logori di vita e di amori altrui. Sradicati, portati altrove da
vortici di vento come vecchi tronchi sterili. Rami secchi per
brevi fuochi, effimeri come il bagliore di una scintilla che t’inganna
di luce, ma non ritorna.
Lei
pensa che si torna verso qualcuno, qualcosa che ti appartiene,
a cui si appartiene.
Mio
caro, e sente quell’affetto, asciutto di odore e sapore,
abbandonarla come un’aura, lo vede incastrarsi in filigrana
fragile nelle due parole, la svuota e la lascia come una specie
estinta, incapace di riprodursi, forse stanca di lottare. È
lì, come un’impronta fossile e lei non può
seguirla. Lei è troppo lontana di corpo e carne, solida
di solitudine.
Mio caro, e non c’è più niente oltre quella
sottile catena di lettere.
Non
sempre si conclude quello che s’inizia. Ad un tratto la
fine si riavvolge sul suo stesso filo, come un gomitolo che si
gonfia sulle dita, e ad ogni giro imprigiona il suo inizio in
un disordine interno che attende di essere dipanato, liberato,
per potersi poi disperdere, forse, in un nuovo inizio.
Lei, ripercorre lentamente con un’unghia le due parole,
accartoccia il foglio e spegne la luce. Lo scintillio di una stella
buca la massa compatta del cielo, lei rimane a lungo a guardarla.
Pranzo
d'autunno
di Giorgio Maimone
Strana
luce. Giornata che tende all'autunno. Tende all'autunno anche
l'umor mio. Tende color autunno anche sulle finestre di casa mia,
in sintonia con i miei anni di castagna.
Il mio mood e' variabile e mutevole
esattamente come il vento e le stagioni.
E' un mood autunnale,
simile alla stagione della vita mia.
Alcune giornate radiose, altre grigie,
altre decisamente brutte.
Ogni tanto cadono le foglie
e il vento le porta via in gioiosi mulinelli,
filtra il sole tra la polvere
e le colora di arancione, di rosso, di marrone.
Color mattone, color bosco, castagna-foglia.
Cosi' gli anni miei.
Anni di castagna.
Col gusto dolce della marronita.
Col senso legaccioso della polpa.
Con gli spilli, infingardi, invisibili e bastardi
del riccio.
Ricordi, ricordi vaghi e imprecisi che corrono sui fili della
luce. Luce poca. Luce che potrebbe anche essere invernale. Ma
freddo non c'e' ancora. Foglie che cadono si'. Foglie rosse, gialle,
vermiglie, ocra. Turbinano un po' per aria e si depongono e dispongono
ai miei piedi. Cerco di prenderle con le mani. Per ogni foglia
afferrata un desiderio che si avvera. Ho desideri? Che importa,
tanto di foglie non ne afferro. Puo' avvenire solo per caso. Fingendo
di distrarsi. Cosi' la vita. Non l'afferri se la cerchi. Puo'
capitare solo di sfroso. Facendo finta. Facendo finta che ...
Facendo finta che non te ne interessi molto.
"Scusi lei ... anzi scusa tu. Facciamo un po' di strada insieme?"
"Non so. Io vado altrove"
"Perfetto! La stessa rotta mia!"
"Se e' rotta perche' non ti fermi un giro a ripararla?"
"Uh! Questo e' quella cosa che chiamano sarcasmo? Era un
po' che non ne assaggiavo..:"
"Ne ho scorte ampie ... e di tutti i gusti. Al lampone, alla
mandorla, alle cozze ..."
"Alle cozze?"
"E' un tipo di sarcasmo ... un po' chiuso..."
"Viscido...."
"...ma saporito!"
"Vabbe', forse e' meglio che vada a passeggiare altrove"
"No, dai sta qua. Dissodiamo gli stessi campi, su!"
"Sui campi mi rompo la schiena. E gia' e' "duro campo
di battaglia il letto"
"Una chi?"
"Una che cosa?"
"Una Chi. Stai citando Una Chi"
"Una chiunque, forse. Stavo citando me stesso"
"Ma sbagliavi, citavi col titolo del libro di un'altra"
"Mica colto io. Incolto, non coltivato. Come un campo pieno
d'erbacce."
"Appunto. Vedi che abbiamo da dissodare un campo?"
"Mi vuoi dissodare o disossare? Gia' non ci capisco niente"
"Parlami di te"
"Uhm. Si inizia cosi' e si finisce a letto, vero?"
"Falso. Non ce l'ho neanche."
"Spero che tu ti riferisca al letto"
"Al letto, a un tetto sulla testa, a uno scopo nella vita..."
"Randagia?"
"Praticamente. Chiamami Lilli ... e il Vagabondo, ovviamente.
Ma faccio tutto da me. Se serve abbaio anche"
"E mordi?"
"Coi proverbi te la cavi male, neh? Can che abbaia ...Can
che abbaia ..."
"Appena smette ti morde! Questa e' la realta'. Non mi dirai
che credi a cavolate tipo "mogli e buoi"..."
"...che pero' e' sempre meglio che non avere una moglie vacca!"
"Aiuto! Qualcuno me la tolga d'attorno! Credevo fosse il
mio ruolo quello di sparare battute sarcastiche. Andiamo a rileggere
il contratto! Vediamo il copione! VOGLIO VEDERE IL COPIONE! Sono
sicuro che queste battute toccavano a me! Se me le rubi tu io
resto senza lavoro"
"Improvvisa"
"Che devo fare?"
"Improvvisa, inventa. Crea. Sii te stesso. O comunque una
copia almeno credibile. Lo so che ti puo' costare dolore... ma
dio santo, qualcosa dentro dovresti pure averlo no?"
"No ... ehm e' che non so ... non ho ... e' cosi' tanto che
... come dire. DISIDRATATO. Ecco. Questo e' quanto. Mi sento disidratato.
Senza liquidi dentro. Per questo bevo. Perche' cerco un modo di
reidratarmi. Qualcosa da bere, per favore! Fate la carita' ma
lasciatemi bere. Qualsiasi cosa. Vino, sangue, sperma, vite..."
"...dalla vite il vino, dalle vinacce la grappa. E dalle
vitacce colpi sulla groppa. Ma groppa d'asino non sale in cielo"
"Questa e' inventata sul momento!"
"Si', lo ammetto. Ma posso fare di peggio. pero' dovrei concentrarmi
di piu'"
"D'accordo. Che facciamo adesso?"
"Questa battuta l'ho gia' sentita"
"Gli avvoltoi de "Il libro della giungla"?"
"Aspettando Godot di Beckett"
"Detto io che sono incolto!"
"E se andassimo a mangiare?"
"Buona idea. Ho voglia di pesce oggi. Ti va il Tintero?"
"Cheschesse' il Tintero? Una tintura a base nero?"
"Madamuasel, e se fosse un ristorante di pesce?"
"Ah no, non voglio andare in ristorante dove il padrone sia
un pesce!"
"Non e' il padrone. Sta nei piatti..."
"E' un lavapiatti? Gia' lo vedo meglio, ma ..."
"SI MANGIA!"
"Ehhh! E che urli? Lo sapevo, sai? Prendevo solo tempo ..."
"Ma se prendi cosi' tanto tempo per scegliere cosa mangiare,
cosa faresti se dicessi che ti amo?"
"Amo ... pesce ... vedo ... intravedo un legame. Va la' che
sei una vecchia lenza!"
"Vecchia, andiamoci piano! Ma tu glissi."
"Glisso, sviscio, striscio, evito, scivolo, sbiadisco, traspaio,
paio e non paio. Maledetti, non mi avrete mai viva!"
"Ma che fatica!"
"Eh si', ma che bello, anche!"
"Sei sposata?"
"Nzo. Oggi che giorno e'? Lunedi'? No, di lunedi' no"
"Martedi' sarebbe stato si', eh?"
"Martedi' SARA' si'! E' diverso."
"Ti sposi stanotte?"
"Naa. Joe Metafora oggi non ne azzecca una! Fatti furbo...."
"Potrebbe essere cosa che riguarda me?"
"Ma tu vuoi sposarmi?"
"Piu' che altro vorrei spostarti ... ho fame. Ecco, ora piove
pure. Mancava questo. Meno male che non e' lunedi' ..."
"Oggi E' lunedi'. Rassegnati. Inizio settimana, piove, fa
freddo e c'e'pure nebbia"
"Niente pesce allora. Giornata piu' spessa, ci vuole cibo
spesso. Il pesce poi rischiamo di vedercelo passare per aria.
Osterie lombarde, ti va? Scegli:
"Lungoladda, Osteria del tempo perso, La colombina, L'angolo,
La barbina., Tenuta il Boscone, Locanda del Sole, Trattoria del
cacciatore, Antica Osteria del Cerreto. Antica Trattoria Mombrione....
"
"Maleo,
Casalmaiocco, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano, Bertonico,
Abbiadia Cerreto, Tavazzano, Corte Palasio...."
"Camini
accesi, bottaggio d'oca, luce fioca, un po' di nebbia. Qualche
brivido".
"Missoltini,
Nervetti, Risotto di zucca al Pannerone, Pollo con luganega e
verza stufata, Lingua bollita, Frittura di pesce gatto, Bolliti
misti, Raspadura, Zabaglione caldo, Cotechino in crosta, Spadellata
di funghi allo scalogno, pure' di castagne e amaretti, Polenta
con anatra, Anguilla del Borgo di Lodi".
"Ricordi,
frammenti, sospiri, sospetti, sospesi. Parole. Poche. In campagna
si pensa. Si tace. Entra la nebbia se si parla. E poi, quando
parli, esce solo nebbia. Taci. Ma guarda".
"Ma guardami e sogna".
"E soffri. Siamo qui. Siamo nati per quello".
"Ti tocco".
"Forse"
"Forte.
Ti tengo. Mi scappi. Mi sfuggi.
Mi resta in mano una tua spallina.
Scappi nella nebbia con la spalla nuda.
Sei nuda".
"Sul fiume?"
"Nel fiume".
"Vicino al fiume".
"Galleggi nel fiume e tendi al mare".
"Ti tendo
la mano
e non trovo parole".
"Ma solo un silenzio
che sa di legna che brucia
e di te".
"Del camino
acceso
li' sotto
al tuo corpo".
"Mi scaldi?
Ho freddo.
Ho bisogno.
Ho voglia di te".
"Mangi con me?"
"Forse ..."
"Uhm, qui si va troppo per le lunghe. Spediamo la prima parte?"
"Fatto!"
Antonio de Paola - L'incidente
di Kosta PREFAZIO.
Certe volte rimango stranito a pensare a quali piccole cose possono
cambiarti una giornata.Non più di una giornata, per carità
, forse due, al massimo tre. Se proprio piccola piccola la cosa
non è, te la ricordi per sette giorni . Ma poi …
pffuu!!! Certe cose sono come il profumo che ti metti addosso
per sentirti profumato tu e per far sentire il tuo profumo agli
altri. Certe cose sono come il tuo lavarti completo, inzuppato,
nell’acqua.Di solito due volte alla settimana Sapete quei
bagni con la schiuma che paiono toglierti la fatica di dosso?
Ecco. Che pare che quando esci ti senti una sorta di dio pulito.
E poi invece finisci per sentire che, se il primo giorno sei ancora
profumato, già al secondo l’odore ed il maleodore
si contendono il predominio delle tue ascelle e dei tuoi inguini.
Ed al terzo giorno sei francamente tornato a puzzare come prima.
Certe cose sono come la presa, raggiante di buone intenzioni,
della Santa Comunione al giorno di festa della Domenica.Questa
storia che vi vado a raccontare è una di quelle storie
piccole piccole, che ti ricamano due punti di affermazione ed
un punto di domanda ad un angolo, ad un pizzo,della tua giornata
fatta a forma di fazzoletto. Non voglio dire di quei fazzoletti
usa e getta, quelli con cui ti pulisci il naso o ti detergi gli
occhiali . No, voglio dire di quei fazzoletti molto più
da conto, di quelli tessuti e stirati con accuratezza, di quelli
su cui ci hai voluta ricamata la tua cifra sopra.
Venerdì
diciotto di aprile. In quest’anno capita che il diciotto
d’aprile sia un venerdì santo.
La mattina io sto regolarmente nel mio studio di dottore in medicina.Di
fronte a me la paziente mi chiede, con finta sofferenza e sicura
impertinente sfida, cosa fare del suo ginocchio divenuto nei lunghi
anni della nostra conoscenza, sì , assolutamente artrosicissimo
. La paziente è una di quelle che portano l’ottantina
e passa con l’idea che neanche i novanta e passa le basterebbero.
Ma mentre dice che si augura “ per non dare fastidio a figli
e nipoti, una morte di subito”, torna a mostrarti il ginocchio
appena appena gonfio ed a fare un giro, una quasi piroetta da
circo, nello spazio angusto dello studio.Per dimostrarti, alla
fine della piroetta, che con quel ginocchio lei zoppica davvero.
Squilla il telefono. E la segretaria mi passa mia moglie:
- Sì , sì … ah …. ma come cacchio…
ah .. ma non è colpa sua?… e va bene.. ma non potresti
andarci tu… Essì … se posso… ma ho due
visite ancora… e che vuoi… venti, trenta minuti…
dipende… ma dove poi.. ah vicino al mercato di via Gramsci….
Ma nennella sta tranquilla? Eggià, non è colpa sua.
Abbasso il ricevitore. E la signora pare aver capito dalla concitazione
della telefonata che per oggi non c’è più
trippa per gatti.Nel senso puro e semplice che la sua artrosi
al ginocchio dovrà aspettare la visita puntuale del prossimo
mese. Ed in quella tornerà a scaraventarmi addosso tutto
quello che, per rispetto alla mia angosciosa fretta percepita
dal mio sillabare telefonico, aveva taciuto. Cioè, tanto
palpitare di cuore e smuoversi e gorgogliare d’intestino
e poi “un dolore qui, ma non proprio qui, un po’ più
giù”. E alla fine, ultimo atto, “ che mio figlio
sono sei giorni che non mi viene a trovare”. La signora
a questo punto sa che la scribacchieria d’una qualche medicina
per i suoi dolori è la giusta conclusione d’una visita
così e così del suo benvoluto dottore. Una visita
così e così nel senso che il suo dottore l’
ha abituata al meglio, ad ascoltarla di più. Ma comunque,
- non dico per dire - lei sa che in quello studio una visita “così
e così” l’ha dovuta subire qualche volta, ma
una visita cialtrona non l’ ha ricevuta mai.
-“Mi stia bene, dottore. E pensi anche un poco a lei ed
alla sua famiglia, che ad andare appresso a noi vecchie ed ai
nostri dolori c’è da impazzire.”
E tutto questo detto uscendo e zoppicando sì , ma meno;
e rigirandosi a salutarti, con un sorriso sornione. Di chi sta
al gioco di malata e dottore, ma ha capito tutto.
Ci si compiace di certe cose e di certi sorrisi. Ma non c’è
tempo più di tanto per ricambiarli e per tenerteli sulla
bocca e poi assaporarteli. Devi inghiottirli e subito. Riprendo
in mano la cornetta del telefono e faccio lo ‘zero’
della segretaria.
- Quanti ne ho ancora?
- Due, ma uno è una cosa da poco.
Io temo le “cose da poco” della mia segretaria. Ma
non perché dopo vent’anni di questo lavoro lei non
sia in grado di valutare la portata del problema. Il fatto è
che a fine mattinata finisce per parteggiare per me e non vede
l’ora che io e lei, entrambi, ci spicciamo.
Però questa volta ha visto giusto. Una influenza appena
agli albori ed un certificato di sana e robusta costituzione.
Esco dallo studio pensando che comunque ho fatto tardi . Il traffico
del venerdì santo ha qualcosa di bestemmievole. Ma taccio,
ed il fatto che mia figlia abbia fatto il suo primo minutissimo
incidente stradale mi rende ancora più apprensivo e cauto
nella guida. Come potrei giustificarle il fatto che per soccorrerla
io stesso mi sono concesso il mio personale incidente stradale?
Niente ci vuole. Ma proprio niente. Basta una toccata all’autoradio
che ti caccia fuori una canzone degli anni settanta che ti fa
ricordare un non so che di primavera avvampata che poi, a cascata,
ti sprigiona ricordi di primosesso. Ma che ci vuole?Arrivo al
posto dell’incidente. Mi aspetto di vedere mia figlia e
gente intorno a discutere di filosofia e dinamica e delle regole
più recondite ed ignorate ed incognite del Codice della
strada.A modo loro- si sa – e perlopiù in dialetto
campobassano, o con un italiano accorato e disdicevole, tutti
parlano dell’ incidente, mischiandolo con quel “del
più e del meno” che tutto è della nostra vita
e di cui niente resta a testimonianza. L’incidente –
ho pensato un attimo prima di arrivare – è come la
moviola del calcio. Quasi sempre dimostra chi ha torto in un fuorigioco
od in un rigore non concesso. Ma poi, chi riconosce le sue colpe
ipotetiche sancite dall’evidenza? Nessuno. Figurati. Intervistati
poi, davanti alle telecamere, allenatori presidenti e giocatori
dicono che questa non è una prova testimoniale, ma però
avevano ragione loro. E però il risultato è giusto
ed insindacabile. Anche se avrebbero meritato almeno di pareggiare.
E, comunque sia, questo passo falso non mette in discussione lo
scudetto Che cazzo sto pensando, e dove me ne sto andando a parare.
Meglio litigare sulle intenzioni del fatto e tirare a campare
. Meglio non chiamare la forza pubblica che comincia a cacciare
il rollino delle misurazioni e poi , nel pieno della autorità
e vestibilità della loro divisa, dopo la sparata, concludono
e verbalizzano che sono comunque e sempre cazzi vostri e delle
rispettive vostre Assicurazioni. Pannoloni per pisciate adulte
venduti a prezzo esorbitante. Io in automobile a volte stradico.
Cioè, mi metto a pensare più del dovuto.Ed invece
nessuno c’è attorno alla Peugeot verde metallizzato
. Però sta parcheggiata bene, penso.Me la rigiro con lo
sguardo camminandoci attorno. Non mi pare che ci sia niente di
diverso. Questa sul parafango di destra è la botta presa
da mia moglie l’anno scorso e quella di dietro è
la botta presa da me appena una settimana fa. Roba conciliata
già. Però, per mancanza di tempo, sta cazzo di macchina
non s’è ancora vista la via di portarla a rimettersi
a nuovo dal carrozziere. Esce mia figlia dal supermercato. Mi
dice : “Papa, che ci fai qua?” Si capisce subito che
avrebbe voluto trovare la mamma. Su di lei atterra sempre sul
morbido. Anche in situazioni come queste.
- Ma allora Rossé?
- Niente, papà, io stavo parcheggiata, ferma, … un
vecchietto con un Ape , il camioncino, affianco a me … e
drunch e drunch, e marcia avanti e marcia indietro, per uscire
dal parcheggio prima di me. Glie l’ho pure gridato, glie
l’ho urlato - devi credermi - che mi stava toccando il muso
di sinistra della macchina mia E lui niente, drunch e drunch,
vicino
Lui niente, sordo. Secondo me è un po’ vecchio, ma
pure rincoglionito. E che cavolo, papà, ma con certa gente
come fai?
- Per favore,. Rosse’ mi fai vedere il danno?
Me lo indica con il dito . E’ una sottile striscia che ha
scorticato appena dieci centimetri del parafango anteriore sinistro
ed è finito, naturale,pure per sbrecciare appena il vetro
dei fari, che costano una madonna di soldi a rimetterli nuovi.
Il primo pensiero che ho avuto è che si può vivere
pure senza di questi casini. In fondo, quante volte ti sei sbucciato
un ginocchio giocando a pallone? E a chi lo dicevi allora? Ti
rialzavi e tornavi a correre. E poi il ginocchio, la ferita, si
rimarginava e ti lasciava quelle cicatrici lineari, bianche, che
non si abbronzeranno mai più. Ma che importava allora.
Però la macchina è un ‘altra cosa. Seminuova
e di tua moglie. Lei non accetterà il compromesso dell’ultima
volta; che sembrava di aver ragione e poi le hanno fatto pagare
i danni e lo scatto della classe di assicurazione. C’è
rimasta troppo male, tanto che quasi se l’aspettava e la
fomentava la situazione che quella fiancata fosse, prima o poi,
stata scalfita da uno che avrebbe avuto torto, torto tanto evidente
quanto marcio, e che , tramite Assicurazione, l’avrebbe
ripagata, con gli interessi , della prima e dell’ultima
botta. In fondo, la macchina, come il quartino di casa, è
la nostra sudata proprietà; è tutto quanto sappiamo
dire di noi agli altri; di quanto abbiamo saputo ottenere dalla
vita. Ed in strada, come ad una riunione di condominio, la difendiamo
con puntiglio e con rabbia, rispolverando espressioni di giustizia
ed ingiustizia che non siamo usi a tirare fuori neppure in situazioni
di gran lunga più eccezionali di queste. Insomma, è
un “guai a chi ce li tocca”. Quasi come i figli. Eppure,
malgrado tutto ho ricominciato a pensare per fatti miei. Quasi
a vanvera.
Prima o poi devo smettere definitivamente. Intanto mi accendo
una sigaretta. Anche di questo devo smettere. Ma una “smessa”
alla volta, per favore.
- Ma dove sta mo’?
- Papà, … se n’è andato, ma ha riconosciuto
che la colpa era tutta sua. Mi ha lasciato questo biglietto. -
E mi porge uno striminzito e sgualcito pezzo di carta , un biglietto
da visita di un negozio di macchine agricole, su cui , a margine,
con scrittura malferma è scritto il suo nome e cognome
e l’indirizzo. Neppure il numero di telefono.
- Ma il numero di telefono?
- Mi ha detto che sta sull’elenco.
- Ma almeno il numero di targa?
Rossella mi guarda tra l’imbarazzato e lo sfastidiato, come
a volermi far capire: “papà, a me hanno insegnato
come portarla la macchina, mica a che succede se faccio incidente!”
E c’hai ragione Rossé. Questo te lo dovevo insegnare
io – penso, ma non lo dico a lei, non sia mai.
Per adesso questi piccoli incidenti della vita me li tengo tutti
per me. Poi …poi si vedrà.
- Ma come t’è sembrato?
- Un bravo cristo, papà. Solo che è vecchio…
e un poco pure…
- Rincoglionito, lo so, l’hai gia detto.
Rossella se ne va tranquillizzata dopo che io l’ho aiutata
– per farle vedere – a far manovra per uscire dal
parcheggio facile facile. Ed a me, appena esco dalla macchina,
mi ferma un mio paziente che stava lì a guardarci mentre
discutevamo.
- Dottò, ho visto tutto.
- Embé?
- No , vostra figlia non c’ entra niente . E’ stato
lui.
- Lui a fare che?
- A fare incidente.
- Ma tu hai visto veramente tutto?
Michelino Stanziale, da quando lo conosco ed è mio paziente,
è uno che passa le giornate a vedere tutto.
- No, io proprio no. Ma mia moglie … sul balcone. Ed indica
la signora al quarto piano
La signora Nunziatina riversata con tutto il suo peso di sopra
sulla ringhiera - non da niente il suo peso di sopra sulla ringhiera
del balcone - mi saluta con la mano e mi fa - almeno così
credo d’intuire - un sorriso d’ intesa.
Io rispondo con un sorriso saputo.
- Va buo’ Micheli’, se servirà qualcosa….
Lo sapevo che l’avrebbe detto, ma io, che cacchio, quella
frase che mi sta tanto sui nervi con quel mio “se servirà
qualcosa” glie la dovevo proprio servire su di un piatto
d’argento, gli dovevo fare proprio da spalla?
- A discposizione, dotto’.
Con la “s “ di “discposizione” strisciata,
servile e furba.
Rientro in macchina mia senza essermi fatto nessuna idea precisa
dell’incidente occorso a mia figlia. E me ne vado a casa
cosciente di sapere e potere ascoltare le angosciose domande di
mia moglie. No, invece mia moglie è nella fase petulante
semplice. Sa che la figlia fisicamente sta bene e quindi mi si
para davanti con fare giustizialista.
- Ci hanno ammaccato la macchina.
- E’ solo un graffio.
- Tu dici sempre così. Minimizzi sempre tutto tu. Come
l’ultima volta…
- L’ultima volta che? - faccio io quasi digrignando i denti
E realizzo che vuole insinuarmi ancora il sospetto che nell’ultimo
incidente provocato da lei, il suo torto marcio, che anch’io
le avevo attribuito in pieno, fosse solo una mia approssimativa
opinione.
Ed un errore, per così dire, giudiziario.Questa donna riesce
pure a non farmi pensare in italiano corretto. Infatti mi ha colto
in pensieri di bestemmie al peperoncino.
- Lasciamo perdere …va. Piuttosto, Rossella come sta? Mica
ha subito qualche contraccolpo… E vorrebbe dire qualcos’altro.
Ma si ferma.
Mia moglie sa che la parola “psicologico” a casa nostra
va usata col contagocce. Si può fare pure della psicologia
spicciola, purché la parola, espressa verbalmente in tutta
la sua pesantezza ed in tutti i suoi risvolti situazionali, resti
ai margini della nostra casa.
Ma questa non è un mio sfizio né una mia fissazione.
E’ semplice prevenzione all’abuso che potrebbe farne
lei una volta che liberamente le concedessi di tenerla tra le
mani.
- Nessun contraccolpo. S’è un po’ mortificata
perché è la prima volta e la macchina era la tua.
Se fosse stata la macchina mia, forse si sarebbe sentita peggio.
- Ma dove sta adesso?
- Dice che andava con Antonio ad aiutarlo in macelleria.
Mia moglie era già pronta per uscire. Raccatta qualcosa
in casa, si riaggiusta allo specchio le labbra col rossetto ed
esce. Due minuti dopo picchia al citofono:
- Io non ho macchina, Rossella ha la mia. Mi butti dalla finestra
le chiavi della tua, per favore?
- Va bene - dico; e le butto le chiavi dalla finestra.
Il “grazie” che mi offre con un sorriso , io alla
finestra e lei giù, è quasi un modo per dirmi che
il peggio per lei è passato. Anche per me. Mi siedo sulla
poltrona e accendo col telecomando il televisore. Certe volte
questa operazione la faccio nelle ore più impensate della
giornata. Un programma vale l’altro. Tanto io non li ascolto.
Mi basta che facciano da sottofondo, rumore, al mio pensare che
sennò non farebbe nessun rumore. E quindi potrei avere
dei dubbi che il mio pensiero esista veramente.Se invece c’è
il rumore del televisore so che i miei pensieri si stanno svolgendo
in un contesto rumoroso. Che poi non valgano niente, perché
sono sopraffatti dal contesto, non importa. Sto lì una
decina di minuti in atteggiamento proficuamente ebete. Poi guardo
l’orologio e spengo televisore e pensieri fasulli.Tiro fuori
quel bigliettino sgualcito. Antonio De Paola.
Faccio congetture sul cognome e sulle mie conoscenze. Di De Paola
ne conosco tre o quattro.
E’ un vecchio. Che sia il padre di Luigi? O di Sergio, il
carrozziere? Eh…magari… sarebbe troppo bello: “Dotto
ve la rimetto io la macchina a nuovo e aggratis e senza discussioni”.
Prendo l’elenco telefonico e verifico che effettivamente
Antonio De Paola esiste ed abita proprio lì dove , con
scrittura incerta, lui aveva scarabocchiato il suo indirizzo.
Forse Rossella non me l’ha detto, ma lui il suo numero telefonico
non se lo ricordava proprio. “ Papà, mi è
sembrato un poco…” “Rincoglionito, lo so, lo
hai già detto. Succede anche a me di non ricordarmi la
targa della mia auto.” Penso di telefonargli subito. E mi
preparo a dire quello che devo dire. Abituato a gente che per
un incidente di macchina è capace pure di negare l’evidenza
e mettere nella contrattazione pure il bene della mamma, mi dico
che devo essere rigido e categorico. Il canovaccio della discussione
è: “tu hai torto e mia figlia, assolutamente ferma
con la macchia, ha ragione. Punto.”
Faccio il numero ed aspetto sette, otto, quattordici ventidue
segnali acustici telefonici. Che mi danno libero ma dall’altra
parte nessuno risponde. Un po’ per inerzia ed un po’
per rabbia arrivo fino al vettottesimo, ventinovesimo, trentesimo
tu-tu dall’altra parte.
Al trentunesimo dall’ altra parte arriva un “pronto”
.
- “ Pronto, pronto” - faccio io quasi trasalendo,
che m’ero distratto a pensare ad altre cose e già
non ci speravo più . Dall’altra parte il “pronto”
mi era arrivato da una voce flebile, trafelata forse da una corsa,
forse solo di una persona anziana. Una voce, tra l’altro,
di quelle che ti danno l’impressione di considerare il telefono
non il mezzo di comunicare con cui si sentono più a loro
agio. E poi, un “pronto” di quelli antichi, come quelli
delle nostre anziane donne meridionali, contadine e sospettose,
che, appena ripreso il fiato, dalla corsa o dalla emozione, cominciano
a gridare dentro la cornetta come parlassero sempre con l’Ammerica.
Pare quel “pronto” una forzatura d’italiano
– come una formula imparata a memoria, per partecipare in
minima parte al progresso - rinunciando ad un dialetto a loro
molto più congeniale e naturale.
- E’ casa del signor Antonio De Paola?
- Sì
- Sono il signor Simonelli, sono il papà della signorina
con cui vostro marito, il signor Antonio … è vostro
marito, vero?…
- Sì
- …vostro marito stamattina ha fatto incidente.
- Come incidente? - mi dice allarmata – mio marito sta qua.
- Ma no, signora, ha appena strisciato la macchina di mia figlia,
niente di grave…
Ma c’è in casa ? ci posso parlare?
- Ma ie nun sacce niente. Sta qua …ma sta fore , sta a “vardà”
l’animali.
- E non lo potete chiamare un momento?
Lei resta perplessa. Io pure resto perplesso del mio incalzare
con le domande .Ho capito che l’ho terrorizzata con la mia
voce in perfetto ed istruito italiano, col fatto dell’incidente
e soprattutto con la veemenza con cui reclamo suo marito al telefono,
come fosse un imputato.
In fondo posso aspettare e ritelefonare fra mezz’ora .
- Va bene, facem’ accuscì , che è meglio,
signo’, io ritelefono stasera. Quando cenate voi?
- A i sette e miez.
- Va buon’ accuscì, io ritelefono, allora . Intanto
vu’ dicete a vostro marito c’ ie hai telefonato.
Il “va buone’ ” di assenso, di tregua, che viene
dall’ altra parte, mi consola.
E così penso riattaccando. E penso che so ancora “spiccare”
un po’ di dialetto accettabile.
La giornata del Venerdì Santo scorre lenta e ad ostacoli.
Con buona pace del Cristo morto. Eppure- dio solo sa- quanto carica
di tanti impegni in questo giorno. Per il Dio Cristo morto e camminatore,
ma in processione, lui, e pure riverito. E di me cristo semplice,
solo vivacchiante e con la deferente “c”, lettera
minuscola; un poco camminatore pure io, ma molto più automobilista
impedito. Solo con un’ opportunità in più
rispetto a Lui. Quella di suonare il clacson.
La Processione omonima , nel senso di Venerdì Santo di
Passione, col solo pensiero di essa, riempie la città.
Blocca definitivamente il traffico. Ed un poco pure la mente .
Essere puntuali in certi posti lungo le direttive dello scorrimento
della processione diventa un obbligo. Mia moglie è una
che vive tradizionalmente queste cose e se la puntualità
non si realizza grugnisce addossandomi tutta la colpa del disordine
cosmico d’una città.
Quando la processione passa e scorre con tutta la sua teoria delle
varie associazioni e confraternite, delle pie donne in fazzoletto
nero e dei bimbetti di prossima prima comunione e tutto il clero
e il monacame sparso e la cittadinanza tutta presidiata dalle
massime autorità che, d’altronde, compuntamente pavoneggiatesi,
seguono proprio immediatamente d’appresso, come a marcare
stretto, il Gesù morto e la Vergine inconsolabile, quasi
volessero ingrazialrseli,
- fessi, i perdenti? - noi siamo là, in un punto strategico
per non perderci nessun particolare e farci un sacrosanto segno
della croce con accenno d’inchino. Ma il pezzo forte della
devozione è il grande coro,diviso in due tronconi, maschi
e femmine, che, al suono della banda, si fanno l’un l’altro
da contraltare ad intonare il greve e struggente canto della Passione.
Ed io ogni anno mi diverto a riconoscerne la gente che, fervente,
presta la propria voce per l’occasione; e a soppesare, per
alcuni di essi, quante e quali siano le credenziali di buon cristiano
al di fuori di questo evento e per il resto dell’anno.E
così scorgo puntuale Geppino il magnaccia che si fa bello
che la sua favorita abbia devoluto il frutto della sua ultima
scopata principe per fare gli orecchini all’ Addolorata.
E Nicola lo spazzino, che prima che il Comune, per quieto vivere,
non lo riconvertisse - a detta sua - ad esclusive operazioni ecologiche,
spazzava e ripuliva strade e condomini… di auto e di preziosi.
Ma c’è poco da scherzare: la fede canterina fa puntuali
miracoli pasquali.
Scioltasi che s’è la processione, la gente sciama
per tutto il centro e se la serata, cosa rara in questi tempi
per queste parti, si presenta tiepida come una sera d’incipiente
primavera, si dilunga per le strade a ritrovarsi in crocchi di
amici e di parenti, a mangiar nocelle americane e a concertare
di pranzi pasquali e di uscite di pasquetta. E, bene o male si
tira a fare tardi.
Tanto tardi oltre quelle ‘sette e mezza ’ pattuite
con la moglie del signor Antonio per la telefonata. Tanto tardi
che decido di rimandarla all’indomani mattina.
La mattina del Sabato Santo si presenta più impicciata
d’impegni che mai. La sera prima ho rimandato due visite
domiciliari che, per quanto non urgenti, direi opzionali, sarebbe
stato comunque necessario fare. E poi, tante visite parentali
per porgere gli auguri, ed altre incombenze pre festaiole; tutti
rituali ben codificati. Come è pure codificato il tempo
meteorologico. Vuole tradizione che per rieditare ogni anno la
tempesta post mortem di Gesù Cristo con rottura di tempio,
anche nel nostro piccolo universo campobassano di Venerdì
e di Sabato Santo faccia acqua e meni vento. E se il Venerdì
Santo quest’anno ce lo siamo quasi scampato infliggendoci
soltanto qualche sparuta goccia di pioggia, oggi Sabato, il cielo
è indiscutibilmente plumbeo e perfettamente in linea con
la tradizione. E, soprattutto, mena acqua - manco a dirlo - come
Dio sa fare.
Mi succede a volte che quando capita che abbia molte o troppe
cose da fare, finisco per stilarmi una scaletta di priorità
elencandole per ordine decrescente di necessità e che poi,
coscientemente, coltivando la mia malcelata indolenza, scelga
di fare solo quella meno importante.Dico, filosofeggiando e parafrasando
la famosa pubblicità carciofesca, che questo è un
modo per proteggermi dal logorio della vita moderna.E la cosa
meno importante della mattinata è proprio risolvere la
questione incidente signor De Paola.
Ma rifletto sull’esperienza telefonica della sera prima.
Se il signor Antonio ha la stessa dimestichezza con il mezzo di
comunicazione che ha mostrato la moglie - e tutto me lo fa presagire
- si perde solo tanto tempo senza capirsi. Con tutto il rispetto
per la sua vetusta età, ma il “rinco” di mia
figlia va affrontato di persona. So bene che tra il tempo inclemente
ed il traffico - anche lui niente male - del sabato prefestivo,
per attraversare la città e portarmi dall’altra parte
di essa, dove il signor Antonio abita, ci vorrà tempo,
olio di freno e marce basse.
Mi riguardo il talloncino sdrucito: via Monsignor Bologna 168.
la zona la conosco abbastanza bene; anzi, conosco proprio la strada;
zona periferica ma signorile, abitata perlopiù da buona
borghesia. “Mah , - mi dico con perplessità - abiterà
con qualche figlio professionista o commerciante ben piazzato”.
Faccio un percorso laterale per provare a circumnavigare il centro
ed evitare il traffico. Non devo essere stato il solo ad aver
avuto un’idea così geniale. Non posso averne la riprova,
ma ,secondo me, dritti al centro si sarebbe fatto prima . Ma questi
sono amletismi da automobilista. Comunque sia, arrivo dopo mezz’ora
ad imboccare la strada dell’indirizzo e comincio dalla metà
circa a controllare i numeri civici dal versante pari: “centoventisei
… centotrentotto… centoquarantadue… centosessantaquatto…
e poi?”.
La schiera degli edifici affilati s’interrompe. Procedo
oltre e mi accorgo che la sequenza delle case sul ciglio della
strada riprende, dopo oltre cinquecento metri, col centosettanta.
“E il centosessantasei? E il centosessantotto?” Mi
rigiro e mi apposto dall’altra parte della strada, circa
nel mezzo di quell’intervallo tra il centosessantaquattro
ed il centosessantotto. Scendo impugnando ed aprendo l’ombrello
e do uno sguardo intorno: aperta campagna. Mi do dell’emerito
fesso ricordandomi le parole della moglie: “sta a vardà
l’animali” E sì che la strada la conoscevo
… Altro che presso figlio commerciante ben piazzato o professionista
… questo signor De Paola vive da solo e dev’essere
contadino puro. Non realizzo ancora bene il perché, ma
la cosa un po’mi sconcerta. Non vedo case di fronte a me
che possano essere o fungere da centosessantotto in quanto la
campagna sale prima su in un discreto pendio e poi verosimilmente
si avvalla.
Mi accorgo camminando a piedi con l’ombrello e sotto la
pioggia che per salire su ci sono ben tre stradine, una è
asfaltata, una è brecciata ed una è poco più
che un viottolo. Per due numeri civici persi nella campagna, tre
strade sono francamente troppe. Risalgo in macchina. A salirci
a piedi non se ne parla nemmeno. Piove , ma anche se non piovesse…
E poi … so già come andrà a finire: con l’intuito
che mi ritrovo in fatto di strade percorrerò prima le due
sbagliate per trovare che la terza è la giusta. Così
è scritto e così è fatto. La prima, la brecciata
, dopo qualche centinaia di metri è senza uscita e mi porta
ad una specie di fienile abbandonato. La seconda, l’asfaltata,
la percorro per più lungo tragitto e mi porta ad una villetta
rustica, ben messa su ,con un ampio giardino ed un discreto parco
macchine. Al cancello il nome è tutt’altro, ma picchio
lo stesso.
“Chi è” , mi risponde una voce femminile al
citofono.
“Scusi, sono un medico - faccio sempre così quando
sono alle strette dell’anonimato per ottenere un po’più
d’attenzione - è mezz’ora che giro per qui
intorno, sa dirmi per caso dove abita il signor De Paola?”
Non mi risponde ma apre il cancello e mentre io procedo, dopo
un attimo, mi appare sulla soglia del portone una giovane signora
che io vagamente conosco.
“ Avevo indovinato. Dottore, ho riconosciuto la sua voce.
Si ricorda? Io sono paziente del dottor Mastromonaco. ( il collega
della porta a fianco nello stesso studio associato) Lei quest’estate
, quando lui era assente, ha curato una brutta allergia a mio
figlio.” Faccio di sì con la testa e sorrido annuendo,
ma francamente, oltre la gradevole figura di sua madre, del ragazzo
non ricordo quasi niente. “Ma entri che piove” e mi
fa accomodare dentro l’atrio.
“Cerco il signor De Paola al numero centosessantotto di
via Monsignor Bologna” “Questo, dottore è il
centosessantasei…De Paola … De Paola… io non
so di nessun De Paola da queste parti… ” “ Dev’essere
un vecchio… un contadino… suppongo…” -
aggiungo io. “Ah… ma allora aspetti…un vecchietto?
…con un camioncino?” “Esatto, un tre ruote”
“Allora veda - mi riaccompagna fuori indicandomi col dito
una casupola a valle che, nascosta tra gli alberi, appena si vede
- la casa dovrebbe essere quella lì, ma per arrivarci deve
ritornare indietro e riprendere per una stradina piccola…”
“Sterrata?... sì… l’avevo notata…
però… “Sì …lo so, ci va stretta
una sola macchina… ma è per una visita ,dottore?
Le mostro la mano libera dall’ombrello e priva della borsa
degli attrezzi del mestiere. “No, è un’altra
faccenda… ha dato col suo camioncino una botta alla macchina
di mia figlia … e quindi il papà deve provvedere.”
La signora mi sorride in modo molto casalingo. Mi sarei aspettato
qualcosa di meglio.
“Beh… io non li conosco quasi per niente… lui
e la moglie … un po’ rustici,direi, però a
vederli quelle rare volte …sempre soli, le dirò,
mi hanno fatto sempre un poco pena.
“Vedremo- faccio io per concludere - è stata gentilissima,
signora, e soprattutto utilissima.” “Ma si figuri,
dottore, piuttosto le posso offrire una tazza di caffè?”
“No, grazie. E’ sabato santo, immagino che siamo tutti
un po’ impicciati… si corre. Le auguro un’ottima
Pasqua a lei e alla sua famiglia.” “ Grazie, anche
a lei”.
Risalgo in macchina pensando, non in ordine di sequenza ma piuttosto
in ordine sparso, a quanto è realmente un bel pezzo di
donna la signora Fantini, che siamo davvero quattro gatti a Campobasso
e, gira e rigira , ci conosciamo un po’ tutti, e che, malgrado
questo, quanto cazzo mi sta facendo penare ‘sto De Paola
per trovarlo. Constato come quest’ultimo pensiero mi stia
montando la rabbia giusta per affrontare un contenzioso da incidente
stradale o, come recita il lessico assicurativo, da sinistro.
Artificio utile per accrescere la grinta che, in queste occasioni,
generalmente non posseggo se non in scarsa misura. E intanto,
finalmente bene indirizzato dalle movenze ben calibrate del di
dietro e dell’avanti e da quel dito indice della signora
Gianna, arrivo alla casupola in una frazione di tempo da cristiani.
La prima cosa che vedo, e che mi conferma che la ricerca è
finita, è proprio l’ Ape camioncino attrice incolpevole
del misfatto. Verdina ed un poco malandata è parcheggiata
sotto una piccola tettoia a fianco della casa. Questa, ad una
prima occhiata, mi si mostra minuta sì,semicadente sì,
ma soprattutto straordinariamente autenticamente contadina. Il
requisito principe di questa autenticità è la promiscuità
che subito cogli, perché strutturale, tra la vita degli
uomini e quella degli animali: accanto ad una striminzita zona
abitativa umana c’è una stalla che prende una parte
non indifferente della planimetria complessiva della casa. E poi
il recinto per le galline e poi , immancabili al tuo arrivo, i
primi ad accoglierti, l’abbaiare di cani il frignare di
gatti ed il tubare di piccioni. E poi ancora, a consolidarti quella
sensazione di essere inopportuno, quel rumore silenzioso di sottofondo,
quel frascare, quel mormorare della campagna che, negli attimi
di silenzio quasi assoluto, dà una sorta di benvenuto a
tempo ad un soggetto straniero.
Districandomi tra la fanghiglia, che la pioggia che non ha mai
smesso ha fatto, avanzo.
“C’è nessuno? Cerco il signor De Paola”
Ed è proprio da dentro la stalla che mi risponde la voce
di chi cerco. “Chi è? Sto qua”.
Entro e l’odore è quello, inconfondibile, di attimi
di ottimi ricordi della mia infanzia.
Magari adesso non lo reggo più di qualche minuto. Ma intanto
è là.E lui il signor Antonio sta proprio davanti
a me mungendo una capra bozzoluta e spelacchiata. Adesso tu che
sei stato studente e poi laureato e hai fatto le scelte che hai
fatto, adesso mi vuoi cavare dal cilindro dei tuoi ricordi letterari,
per benaccetto pavonismo culturale, un po’ di Virgilio?
Fai! Ma se delle Bucoliche, a tradurle, ti arrangiavi il sei scarso.
Il senso è un altro; diverso da quello che altri volevano
farti imparare a memoria . Tu queste scene le hai viste. Sì,
da bambino, e non mai da figlio di pecoraio, ma l’atmosfera
era quella. Anche se tuo nonno era massaro.
E che cazzo! Nel sessantotto c’avesti pure a che ridire
sui proprietari terrieri, sul latifondo
E t’incazzasti pure con tuo nonno che non voleva capire.
E vi metteste il muso.Però poi lo baciasti sul finire del
suo canuto volerti bene comunque. Ed allora adesso mi chino un
po’ a guardare il mio Antonio De Paola contadino e la sua
capretta e questa inaspettata mungitura ad un tiro di sputo dalla
mia città. Resto muto , tanto vorrei rifarmi tornare gli
occhi del bambino di allora. Ma resto muto.Tanto che è
lui, chinato di lato con la mano che cerca e spreme la mammella
penzolante e da questa schizza latte nel pentolino di ferro bianco
smaltato e orlato d’azzurro , che, senza parlare, mi fa
con un moto scocciato di occhi e con un gesto del capo: “che
vuoi?”
“Signor De Paola, sono …. - e tutta la tiritera….
l’incidente, mia figlia , la macchina ed il suo “drung
e drung” col camioncino. “Ma faccia … finisca
con comodo” Lui certo non se lo fa ripetere; ti scruta di
sbieco centrandoti nel suo mirino di naturale diffidenza contadina
e procede nell’operazione. D’altra parte so bene anch’io
quanto sia dissacrante e doloroso praticare ad un animale la mungitura
interrupta: viene acido il latte. Io che intanto me la godo, ho
tempo per modificare il mio “lei” del tutto inopportuno
e caricare nelle mie corde un “voi” appena più
informale. E poi di guardarmelo per bene il mio signor Antonio,
con la sua faccia grinza e spigolosa arrivata al canonico sesto
giorno di barba non fatta - i cafoni veri, quei pochi rimasti,
dalle mie parti santificano la festa rasandosi la barba solo la
Domenica - che spunta sul viso in peli ispidi e bianchicci. La
camicia di flanella a quadri rossi e strisce blu e sopra un gilettino
svolazzante depauperato di quasi tutto il suo colore originale
ed infiorato da macchie multiformi. Dai polsi mani nodose e vispe
e in testa un cappelluccio sformato, grigio, di quei grigi direi
quasi indifferenza, di feltro, quasi solo appoggiato sul cucuzzolo.
Una specie di divisa d’ordinanza, credo, per tutte le stagioni.
Unica concessione ai tempi moderni ed - ahimé - troppo
poco lenti, uno sgradevole orologio da polso. Che fa il pari -
doppio ahimé - col suo andare a vendere la roba al mercato
da motorizzato. E mentre io già m’avvilisco d’essere
venuto qui, in questo posto che in qualche modo sa di sano e di
antico, a perorare una causa tipica della nevrosi dei tempi nostri,
lui si rialza con la flemma e con la cautela tipica dei vecchi
, si strofina le mani sul pantalone alle cosce e mi tende il solo
dito mignolo della mano perché io lo stringa in segno di
saluto. Va sottinteso che la mano me l’avrebbe data tutta
se non si fosse fatto scrupolo che era sporca. Mi dice con solennità:
- “C’ avete ragione, ho sbagliato e devo pagare il
torto”. Manco fosse una colpa da espiare.
- “Ma ce l’avete l’assicurazione, signor Antonio?”
- “Ce l’ho. Poi aggiunge: “se m’ so’
recurdat’de pajarla.”
- “E bisogna che controlliamo” gli faccio io, non
so se più per premura d’aiutarlo o perché
è oggettivamente mio interesse.
Mi invita a salire su . Usciamo dalla stalla e saliamo lemme lemme
per una scala stretta e dai gradini consumati e ci troviamo dentro
ad una stanza che deve essere la più grossa della casa
e che fa da soggiorno e da cucina. Al tavolino la signora Carmela,
quella intirizzita dagli strali vocali del ghiaccio di italiano
perfetto della mia telefonata, sta scegliendo la verdura. Una
cosettina di nero vestita, ma meno imbarazzata di quello che m’ero
potuto immaginare per telefono. Dopo che il marito mi ha presentato
come quello della botta, mi invita a sedere.
-“Iere m’avite fatte piglià ‘nu spavente.
Assettateve”. E lo dice con una voce tra il perdonante ed
il tagliente. Una specie di rivalsa dal vivo. Io sorrido scusandomi
e mi siedo. Intanto il signor Antonio sempre all’in piedi
ha cominciato a smanettare con evidente imperizia e sfastidio
tra un mucchietto di carte estratte da un cassetto. E lo fa così
di malavoglia, con quasi odio per quelle carte, che ogni tanto,
con indolenza, se ne lascia scappare qualcuna di mano. Come se
tra pollice ed indice riuscisse a scalciarle. Inforca gli occhiali,
che sanno di grande occasione ma che hanno una stanghetta riattaccata
alla meglio con nastro adesivo, e se li piazza un po’ storti
sulla punta del naso. E mi porge prima un bollino d’assicurazione
del duemilaeuno e poi uno del duemilaetre.
- “ Ma quist’ann’ la sci pajata?” l’incalza
la moglie.
- “ E se lu sapess’…” gli risponde dandogli
un occhiataccia da dietro le lenti, e , rivolgendosi a me: “Sti
femmene n’ ze sanne fa’ mai i fatte lore.”
E’ chiaro che sta per esaurire la sua pazienza cartaiola.
D’altronde ognuno di noi ha un livello di soglia di sopportazione
per la burocrazia. La sua è solo molto bassa. Lui magari
odia anche il maneggio del semplice denaro; per procurarsi le
necessità da vivere il suo sistema principe potrebbe forse
essere il baratto. Ma no, adesso sto esagerando… c’è
un po’ di cattiva ironia in quello che penso e nella domanda
che mi sta venendo in testa di fargli.
Perciò, con curiosità quasi apprensiva, do uno sguardo
indagatore lungo tutta la stanza soggiorno e la cucina. Vedo il
telefono della telefonata ed una radio di quelle quasi scolpite
nel legno, dal modello piuttosto sorpassato. Di quelle che oggi
so di gente che farebbe carte false per averle. Perché
non fanno notizia – sono perlopiù allo stato gracchiante
– ma fanno arredamento. Poi c’è il frigorifero,
piccolo ma c’è. Non scorgendola, con una gradevole,
strana, intima premonizione, penso: “vuoi vedere che non
ce l’ hanno”? Lo so che nel contesto è una
domanda che non c’entra, ma chiederlo è ormai diventato
più forte di me.
- “Ma voi ce l’avete la televisione?”
- “Come?” mi fa lui, per vedere se ha capito bene.
- “Sì, dico, ce l’avete la televisione?
Si guardano interdetti tra di loro e mi guardano interdetti riappropriandosi
immediatamente di quella diffidenza nei miei confronti che, dopo
i primi momenti, si era andata attenuando.
- “Ma ‘mo quessa cosa ch’ c’entra cu’
la questiona nostra?”
E che dovrei rispondergli io adesso? Che questo vederli così
mi sta regalando la gradevole sensazione che il tempo si sia parzialmente
fermato, che dentro questa mia città gaudente fino alla
tronfietà della sua incosciente epilessia, esistono ancora
sani focolai di resistenza, anticorpi inaspettati di buon senso,
oasi di ‘me ne fotto’ ?
Lo so che il senso ed il contesto di questa mia venuta sta cambiando.
Anzi, è cambiato appena ho visto lui e la capretta fare
quasi all’amore.
Mi riprendo.
- “No, niente… dicevo così … a volte…
al telegiornale… sono loro che ti ricordano le bollette
da pagare”- invento senza pormi il problema d’essere
creduto. Godere di una spudorata incredibilità è
un lusso che mi concedo, purtroppo, solo ogni tanto.
- Sì, la teng’ Me la vulètte arregalà
fìglieme. Ma po’ z’è rotta e nun la
song fatta accuncià cchiù. Sta menata pe’
dentr’ a lu sgabuzzine. A me m’ piace de sentì
la radie.
S’interrompe un attimo per riflettere sui massimi sistemi
delle sue conoscenze.
- “Sì , ma nisciuna radie m’ha mai recurdate
le bullette d’assicurazione ca z’ avévana pajà.
Ch’ avìmma fa’ cu sta carta ca nun ze trova?
Bella domanda signor Antonio, bella domanda, davvero. Pratica,
da vero contadino.
Attento però, signor Antonio, attento perché il
cittadino automobilista padrone e proprietario del bene incommensurabile
della sua automobile, questo cittadino che voi, voi due adesso,
senza saperlo, state blandendo e quasi immobilizzando con la vostra
genuina ed ingenua essenzialità, questo cittadino che incravatta
regole e confeziona pacchi spesa secondo spot pubblicitari e notizie
di telegiornale e poi , nel suo piccolo, per discolparsi, incasella
cubetti di pensiero dello spessore della nebbia - manco fossero
diamanti o la quintessenza della Luce - questo cittadino, dico,
potrebbe riappropriarsi d’un’ altra praticità.
Diversa dalla tua anche se , in qualche modo, uguale.
Quella che ti chiede:
“E allora, signor Antonio, si potrebbe fare che io la macchina
me la faccio vedere dal carrozziere, mi faccio valutare il danno,
- non hanno cuore i carrozzieri, loro valutano il danno alle macchine,
mica alle persone - e poi , dopo averlo sentito e lui dettomi
a quanto ammonta il danno, mi ripianto qui e ti dico tipo: “centocinquanta
euro ad esser buoni. Per te, perché sei un povero cristo
con la “c” più minuscola di me, che, per esempio,
ieri è andato solo al mercato a vendere la sua robbina
della sopravvivenza con il suo camioncino della sopravvivenza
, e , siccome il tuo camioncino non lo ami per niente e non hai
voluto mai imparare a guidarlo per bene, - non è che sei
“rinco” come sostiene mia figlia, non è l’arteriosclerosi,
non solo quella - era fatale che tu facessi il “drung e
drung” con la macchina di Rossella. Non vai mica alle processioni
del venerdì santo, tu. La tua “c” è
nata o e diventata troppo striminzita per aver mai pensato a fare
di queste cose. Centocinquanta euro di tuo. Trecentomilalire Hai
capito, signor Antonio? Hai capito, signor Antonio, che sono stanco
di pensare? Di trangugiare i miei pensieri appena mi colano dalla
testa e mi arrivano a fiotti a fior di labbra. Ed allora, caro
signor Antonio, ed anche tu, signora Carmela, forza, mettetevi
d’impegno a liquefarmi completamente questo vermicolante
cervello cittadino.
Ecco, parlatemi dei vostri figli. Uno, Nicolino che ormai sono
trent’anni che sta in Canadà , e l’altra, Linuccia,
“la maestrina,” a Lambrate - “sì, si
pronuncia proprio così, l’avete detto bene”
- praticamente Milano. E che hanno ormai perso la voglia e la
via del ritorno.
- “Ma ch’ hanna venì a fa’ qua? Tènnen
la lore famiglia. Pure quelle rare vvote ca venne… a vedet’
a casa quant’è piccerella? C’ accampàme
com’ i zingare”
- “Ma voi… di andare su?”
- “ Quacche vvota, ogne tante. L’utima vvota l’estate
passata, pe’ la prima comunione de Tonino, mio nipote. Linuccia
ce vulesse sempe là , stabilmente, ma ie ‘ngoppe,
nun ce facce l’aria. E po’, ce stanne sti quttr’
anemale da vardà… dui cucuccielle (zucchini) i pummadore,
nu poc d‘nzalata… Finché u’ Padreterne
me da la forza, a me m’ piace ancora de furgià (di
darmi da fare) pe’ arrangià quaccosa... Magare essa
- ed indica la moglie - ‘ngoppe da la figlia ce stesse cchiù
volentieri a crescese i neput’… Sa, i femmene ze adattene
de cchiù…
A cucena’ e a pulì la casa è uguale a tutt’
i vie”.
-“ Anto’ tu tiè ragione, ma a uttant’anne
quasce, nun ze po penzà de campa da sule. Basta ‘na
piccula malatia e Antonie e Carmela nun ze avezene (alzano) cchiù.
- “Essì, ma lu vuo’ capì che a me basta
nu mese ‘ngoppe e m’avvelische. Fosse comme aspetta’
la morte, ferme e quiete.”
Basta guardarli. Ho innescato un discorso tra di loro forse preso
interrotto e ripreso decine di volte, che riguarda la loro prospettiva
prossima e questi loro ultimi spiccioli di esistenza . Continuano
a parlare davanti a me, quasi a litigare, ma a schiaffetti e carezze:
sembrano due gatti che giocano a fingere unghiate. A momenti è
come se io non esistessi, non fossi presente; a momenti, invece,
mi chiamano quasi a giudice delle loro ragioni; nell’un
caso e nell’altro mi danno il privilegio di farmi sentire
a mio agio, come uno di casa. Perché queste storie io le
so, le conosco. Ce ne sono state e ce ne sono probabilmente ancora
tante dalle mie parti. Solo che io avevo incominciato a dimenticarle.
Con disappunto e con un po’ di vergogna mi accorgo dal mio
orologio da polso che si sta facendo tardi. Loro adesso vorrebbero
continuare a parlare. Dirmi come tre mesi fa al signor
Antonio, appena uscito dalla Posta, un giovinastro gli ha strappato
il portafogli di mano e due mesi di pensione se ne sono andati
in fumo, e lui se ne stava facendo una malattia. E adesso
pure l’incidente di ieri mattina…E dunque?
Li interrompo quasi accarezzando loro le mani. Perché sono
belli. Perché sono teneri. Perché lui ha finito
per ricordarmi mio nonno e, ancora di più , Pasquale, il
mezzadro di mio nonno e il suo parlare di Bianchina, la vacca,
come della sua innamorata. E lei mi ha fatto pensare a mia nonna
che non ho mai conosciuto se non attraverso i racconti di mia
madre.
- “Riguardo all’incidente, signor Antonio, non ci
pensate”
- “Come?”.
- “E’ fesseria, me l’aggiusto io la macchina
e non se ne parla più”.
Non si fa capace. E devo insistere. Devo dirgli che sono dottore,
che ho un paziente che fa il carrozziere e che mi fa prezzi di
assoluto riguardo… “Anzi , a proposito, proprio perché
sono dottore… speriamo che non serva mai, ma sa… se
doveste aver bisogno di qualcosa… questo è il mio
bigliettino da visita col numero di telefono”
Adesso sono loro che mi guardano come imbambolati, investiti come
sono da questa inaspettata mia ondata di buona creanza.
- “Aspettate - faccio - scendo giù in macchina un
momento e torno subito”. Mi sono ricordato che in macchina
ho una confezione di colomba pasquale ed una bottiglia di Strega
regalatimi da un paziente il giorno prima.
- “ Di questa ne mangiate una fetta domani e , se vi va,
ci bevete su pure un bicchierino alla mia salute.”
Sono straniti ma mi sorridono. Non si schermiscono neppure più.
- “E’ che mi ha fatto un grandissimo piacere conoscervi”.
Vorrei far loro capire che ha un senso forte, non solo quello
convenzionamente ipocrita, quello che sto dicendo. Vorrei usare
altre parole, ma non so se le capirebbero. Perciò confido
nell’intesa sancita tacitamente dall’evidenza dei
fatti.
- “ Carmé, va… piglia dell’ova a ‘u
dottore. Carmé… pigliacele tutt’ quante, ch’a
nuie ce ne bastene tre pe’ la frettata de Pasqua. Quanta
figlie tenete?... Ah, sule quella c’hai canusciute?
‘Na bella signurina, educata.”
Intanto Carmela è scappata giù nel pollaio starnazzando
di contentezza; e ritorna con tante uova che le mani ne sono piene
e scoccoleiano pure le capienti saccocce . Sistemandole in una
busta ne rompe una; e scoppia a ridere; sorride severo pure il
marito.
- “Adesso devo proprio andare”.
Vengono giù anche loro e mi salutano con la mano mentre
mi risalgo in macchina e aggiusto sul sedile davanti la busta
con le uova e risistemo lo specchietto retrovisore; perché,
mentre scendo, possa dare loro ancora un’occhiata. Io adesso
lo so che basterà scendere di sei, settecento metri questo
breve e stretto viottolo per rientrare come per incanto nel mio
scenario consueto, nel mio mondo, per le mie strade colme di traffico,
cariche di orgasmi precoci, e perciò impudici. E ritrovarmi
in posti dove la lentezza è una penalizzazione inconcepibile,
dove l’ ascoltare ed ascoltarsi troppo dentro arreca sicuro
danno. E non mi salverà neppure quel mio vizio saltuario
che mi spinge a farlo davanti ad un televisore o sull’automobile.
Eppure almeno adesso, e non so per quanto, mi sento addosso una
sensazione di candore, di soave pulizia.
Chissà se il signor Antonio domani mattina si laverà
e si insaponerà di tutto punto rattrappendo le sue gambe
ossute nella vaschetta di ferro smaltato lunga un metro scarso,
se si sbarberà per benino, e se la signora Carmela gli
farà indossare la camicia bianca della festa, fresca di
bucato e col colletto inamidato.Se i figli chiameranno dal Canadà
e da Lambrate per gli auguri?
Perché domani è Pasqua.
La
donna a tempo
di Lisa
No,
lei non era una puttana, ma forse se lo fosse stata, sarebbe sicuramente
stata fra le migliori che si potessero trovare lungo le squallide
strade di periferia. Fra le sue braccia, gli uomini avrebbero
trovato esattamente quello per cui pagavano, poche ore d’amore
e la sensazione, seppure momentanea, di non essere più
soli.
Ma il destino non le aveva riservato quella fortuna perché
almeno, lei si diceva, le sarebbero state risparmiate non poche
delusioni, non poche ferite. Se non altro avrebbe saputo fin dall’inizio
che il compenso per ogni parola, ogni carezza, ogni ora condivisa
con gli altri, sarebbe stato al massimo un paio di biglietti da
cinquanta, forse più o probabilmente meno, ma questo non
aveva importanza.
Si sarebbe infilata nelle macchine di sconosciuti aggiustandosi
sui fianchi la minigonna rossa, mostrando le sue calze a rete,
avrebbe fatto finta, se gli fosse stato richiesto, di ascoltare
e di essere felice mentre faceva l’amore a tempo, così
come il lui occasionale avrebbe finto di poterla amare. Dopodiché
lei avrebbe riposto la ricompensa che le spettava, nella minuscola
borsetta. Avrebbe risistemato la gonna e le calze, e ripassato
sulle labbra un velo di rossetto guardandosi nello specchietto
alla luce fioca dell’abitacolo, prima di scendere dalla
vettura.Lui avrebbe messo in moto allontanandosi senza nessuna
esitazione, ma con aria soddisfatta, e quasi sicuramente non l’avrebbe
più rivisto. Niente telefonate, lettere o inviti a cena,
fra lei e i suoi clienti, un solo tipo di rapporto, quello che
fra due persone è il più chiaro e limpido al mondo,
una soddisfacente ora di sesso ben pagato e ben retribuito, senza
nessun’altra complicazione.
Il suo tempo, ogni suo gesto avrebbe avuto un prezzo, l’esattezza
contabile di un dare e di un avere.Ma lei non era una puttana,
e la sorte non le aveva dato la fortuna di essere neanche una
donna delle pulizie, una di quelle che chiami una volta alla settimana,
ma se lo fosse stata sarebbe stata di sicuro la più richiesta,
una di quelle che sanno fare alla perfezione il proprio mestiere
e che sanno dal primo momento che da ogni appuntamento non avrebbero
avuto da aspettarsi null’altro che lavare piatti e panni
sporchi.Con efficienza e dignità avrebbe riportato ordine
e pulizia nelle vite di annoiate o indaffarate signore, restituendo
la giusta compostezza alle loro cose.Sarebbe entrata e uscita
cento volte da altrettanti appartamenti, pulendo e sistemando
ogni angolo, sfiorando la quotidianità nascosta in tutti
i piccoli oggetti rispettandone però, come da contratto,
con pudore e discrezione, ogni intimità.
A lavoro finito si sarebbe tirata giù le maniche della
camicia, e avrebbe preso fra le mani arrossate il suo compenso
che poi, con cura, avrebbe sistemato nel portafoglio di similpelle
nero, mentre, forse, le sarebbe stato detto un “grazie,
ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando sia puntuale”.
Poche ore di silenzioso e scrupoloso impegno scandito da una tariffa
prefissata, l’esattezza contabile di un dare e di un avere.
E lei non era neanche una bottiglia di buon whisky, ma se lo fosse
stata sarebbe stata una delle migliori, forse non la più
pregiata e raffinata, ma una di quelle che puoi avere fra le mani
pagando un prezzo equo.Una di quelle che si comprano tornando
a casa, sapendo che da quella sera non ci sarebbe stato più
nessuno aspettarti. Ti avrebbe fatto compagnia riempiendo di calore
e stordimento le ore di ricordi e solitudine e avrebbe dato, bicchiere
dopo bicchiere, una fugace assoluzione a tutti i tuoi errori.
Un sorso dopo l’altro ti avrebbe illuso con la sua liquida
trasparenza, e confortato con la pienezza del suo sapore. Ma fin
dalla prima goccia sarebbe stato chiaro che l’indomani,
vuotato l’ultimo bicchiere, soltanto la solitudine sarebbe
ritornata ad abitare il tuo appartamento.
Una bottiglia ed una sola notte a poco prezzo passata in un offuscato
torpore per ingannare fino al mattino il vuoto di una stanza,
l’esattezza contabile di un dare e di un avere.Lei non era
nemmeno un verso ma se lo fosse stato sarebbe stato uno di quelli
che non resta chiuso fra le pagine polverose di un libro vecchio
di un biblioteca. L’avresti trovato scritto probabilmente
sul bigliettino che avvolge un cioccolatino e per un po’
l’avresti conservato nella tasca e riletto di tanto in tanto
perché, quelle poche righe, avevano proprio le parole che
avresti voluto sentire in quel momento, o forse perché
un tempo qualcuno te le aveva sussurrate in un orecchio. Sarebbe
stato gelosamente serbato fra le pagine di un diario fino a quando
sarebbe stato dimenticato, lasciando il posto forse a un nuovo
verso, forse a un nuovo amore.
Un sottile e minuscolo foglietto che con il lento svanire del
profumo di cioccolato avrebbe reso un amore finito meno amaro.
Poche parole che presto non avrebbero avuto più importanza
in cambio di un malinconico ma dolce dissolversi di un sogno,
l’esattezza contabile di un dare e di un avere. Ma lei non
era niente di tutto questo.
Lei era una tranquilla signora che si avviava ormai con noncuranza
verso i quaranta. Era gentile, cordiale, mai scortese. Era sempre
stata così, e soprattutto nel suo modo di sorridere si
poteva cogliere tutta la sua istintiva e naturale dolcezza. Gli
occhi le si chiudevano quasi, disegnando una fitta rete di piccole
rughe che a raggiera si allargavano fin sulle tempie.
I suoi occhi, due ragnetti in agguato sulle trame delle loro ragnatele
quando la bocca si socchiudeva in un solare sorriso. Gli altri
lo apprezzavano con lo stesso gusto con cui a colazione davano
il primo morso al cornetto intinto nel cappuccino. Dava ristoro
ed energia cancellando il gusto amaro della notte. Era come il
caffè portato a letto la domenica mattina, quando fuori
piove e non hai voglia di lasciare il calore delle lenzuola e
hai la sensazione di avere tanto tempo a disposizione e che lo
puoi trascorrere nel migliore dei modi.
Se lei sorrideva veniva naturale ricambiare il suo sorriso.
Lei era così, ma soprattutto lei aveva il dono di sapere
ascoltare.
Lei intuiva quando qualcuno aveva bisogno di parlare, o di affidare
le proprie ansie, paure, delusioni a chi sapesse, sia afferrarne
il corretto significato e darne il giusto valore, sia maneggiarle
con cura, come se ogni parola a lei confidata avesse la stessa
fragilità di un cristallo di Boemia.Lei era il faro nella
notte quando le burrasche arrivavano, aspre e inattese, nella
vita dei suoi vecchi e nuovi amici. Ogni volta si lanciava in
loro aiuto, si dava tutta . Lei era lì, presente, con la
ferma convinzione che il tempo a loro dedicato era esattamente
complementare al legame che li univa.La calma poi tornava e lei
ogni volta si ritrovava nel suo tranquillo porto, sola.Pochi uomini
l’avevano amata.
Si erano aggrappati a lei mentre, come cuccioli randagi, si aggiravano
senza meta fra i sentieri delle loro scelte. Tra le sue parole
avevano trovato un riparo, un posto dove le ombre della notte
non si allungavano minacciose, come se lei avesse avuto il dono
naturale di trovare ogni volta una dolce ninna nanna che riuscisse
a rassicurarli prima di dormire, facendo dimenticare loro tutto
il resto. Da quel suo modo di essere donna, da quel suo mondo
dove riusciva ad essere sempre pronta a ricominciare, avevano
attinto ogni segreto e la capacità di affrontare le sconfitte
e di andare sempre avanti.
E poi i cuccioli impauriti acquistavano forza e fiducia a sufficienza
per andarsene ognuno per la propria strada.
Di quelle storie non rimaneva quasi niente se non qualche lettera
o una telefonata quando qualche piccola nuvola attraversava di
tanto in tanto i loro cieli.
Si, lei per tutti era null’altro che una donna a tempo.
Di lei ci si poteva dimenticare, magari la si poteva anche buttare
come un vecchio quaderno con le pagine ormai già tutte
scritte.
Lei raccoglieva i loro dolori come in un vaso e nel conservarli
li faceva suoi. Li liberava da ogni peso, restituendo loro la
curiosità e la leggerezza per poter poi andar via. A lei
restava solo un gran vuoto e il poter solo immaginare i loro ritrovati
sorrisi.
Poi tutto ricominciava, qualcuno la chiamava.
“Passo da te più tardi.”
Lei sorrideva pensando al nuovo piccolo dramma che l’aspettava.
Negli anni ormai aveva imparato che quelle poche ore, che avrebbe
trascorso raccogliendo i cocci dell’ennesimo amore finito,
dell’ennesima delusione, dell’ultima sconfitta, e
l’illusione, anche temporanea, di non essere così
sola, sarebbe stato il suo unico compenso.
L’esattezza contabile di un dare e di un avere.
Sì, forse lei avrebbe potuto essere anche la morte, ma
non lo era, però se lo fosse stata sarebbe stata quella
che alla fine tutti ci si aspetta.
Avrebbe atteso con pazienza lo scorrere del tempo e avrebbe lasciato
silenziosamente che ognuno rincorresse i propri sogni, non avrebbe
creato intralci né ai momenti di amarezza né ai
giorni di spensieratezza. Come un’ombra avrebbe seguito
passo passo il lento consumarsi della vita. La sua sarebbe stata
un’esistenza discreta senza rubare neanche un attimo al
tempo che era stato concesso, per rivelare solo alla fine la sua
presenza.
Un’attesa lunga una vita e un unico fatale istante, in equilibrio
sui piatti della bilancia.
Sì, l’esattezza contabile di un dare e di un avere.
Lezione
di Mate
di Bruno Giuliano
Greco
Pierino, Pigreco per gli amici, nonostante il soprannome, non
era tagliato per la matematica o forse non gli interessava, come
é abbastanza naturale tra gli adolescenti.
I suoi pensarono bene di mandarlo a prendere lezioni private dalla
professoressa Costante, amica di famiglia da lunga data. La Costante,
Kappa per gli amici, non poteva proprio definirsi una bellezza
e sopperiva alla scarsità di fascino intrinseco indossando
gonne sufficientemente corte da estrinsecarsi abbastanza in alto
sulle cosce quando si sedeva ed accavallava le gambe. Questo avveniva
soltanto nel suo studio, poiché prudentemente in classe,
un lungo camice nascondeva quest'estrema risorsa.
Da un paio di giorni, ossia dalle sue due prime lezioni, Pigreco
aveva intuito il valore incognito tenuto sotto radice da quella
gonna ed aveva pensato di installare uno specchietto sulla punta
della scarpa memore delle lezioni di fisica ottica. Chiuso nella
sua cameretta aveva fatto la prova del nove scartando infine l'idea.
Risolse il problema sostituendo la variabile specchio con le scarpe
da discoteca, quelle con la punta di lucido acciaio riflettente
allora tanto di moda.
Ora era pronto e quando il giorno successivo si sedette dal suo
lato della scrivania, non dovette far altro che inclinare il piede
di alfa, ruotare la caviglia di beta, allungare la punta di delta
X e godersi la vista di un paio di mutandine in cotone. La pur
essenziale geometria fu comunque sufficiente a stimolare una crescita
lineare del grafico del piacere, la famosa curva "G",
ma non si recò in bagno prima del ritorno a casa.
L'indomani, inaspettatamente, le sue manovre periscopiche vennero
premiate dalla vista di splendide mutandine traforate ed orlate
di deliziosi frattali. La curva "G" s'impennò
in modo esponenziale ed egli partì per la tangente, ossia
chiese il permesso d'andare in bagno, lì e subito.
Il terzo giorno, l'equazione sotto analisi s'era ridotta ai minimi
termini non essendoci più niente ad offuscare la visione
della parte aurea, mentre la crescita della "G" divenne
asintotica tendendo alle ascisse, al limite della tenuta della
patta. La semplice alzata di un dito bastò a concedergli
l'uso del bagno dalla comprensiva insegnante.
Il quarto giorno si aspettava ovviamente l'infinito, invece ritrovò
la donna in pantaloni. Vacca boia, questo cambiamento di segno
non se l'aspettava proprio.
La professoressa lo guardò sorniona e gli disse:
< Esistono anche funzioni discontinue, oggi sono nell'intervallo
non definito, ma non ti preoccupare per la provvisoria inagibilità
perché le lezioni continuano al piano superiore. >
Ciò detto la professoressa sollevò la maglietta
e racchiuse il prospero seno in faccia all'allievo come tra due
parentesi tonde.
< Ammira! Questa non é piatta geometria euclidea, qui
c'é la quarta dimensione, quella dell'eros. >
Pigreco credette di soffocare mentre lei cercava freneticamente
di estrargli la derivata prima, (i pantaloni) e poi la seconda,
(le mutande) per ridurlo alla nuda essenza d'una curva orizzontale.
(semplificando i termini: lo stravaccò sul sofà)
Ma per la media non ponderata tra il quadrato dell'emozione e
il cubo dello spavento, la curva "G" dell'adolescente
cadde verticalmente tendendo a zero nonostante, anzi, forse proprio
a causa della logaritmica azione del donnone. A nulla valsero
i tentativi di lei per rielevarlo a potenza ed il ragazzo fuggì
lasciando irrisolta l'equazione portandosi via l'indispensabile
primo membro.
La matematica lo lasciò andare sconsolata e palpandosi
i generosi seni e coscieni, dedusse che non si poteva postulare
che Pigreco fosse razionale: sarebbe stata una tipica dimostrazione
per assurdo.
Maturità
di Kosta
Come
in un sogno, consueto ormai, sognai la stanza e la situazione
degli esami. Ma diversa. Per notti e notti, accorciate dal fare
tardi per studiare ed alzarmi presto per studiare, già
col sonno ero in debito. Ed in questo, si striminziva ormai un
sogno anemico, timido e di pura paura ..E diveniva ormai, col
mio predispormi ad evitarlo, un incubo, sempre uguale. Sognavo
le prove scritte come un foglio che, dopo ore di soliloquio mentale
e non solo, si riempivano solo di ideogrammi intraducibili, come
apostrofi di rabbia, maledicenti le strategie assurde del tuo
studio; i risultati: abbozzi di note stonate d' un tema d'italiano,
travisazioni sintattiche d'una versione di latino, roteare anarchico
di cifre intorno al buco nero della soluzione d'un compito di
matematica. Lucidamente il quadro del sogno si arricchiva della
catastrofe dell' " orale." Ad aggiungere onta ad onta,
ogni esaminando della storia prefigura la sua fine ingloriosa
con la figura-dramma della " scena muta". Che in qualche
modo è meno ignomignosa del gutturale sussurrato e del
dimenarsi della faccia, della lingua, della bocca e della mente
che provano a parlare d'un argomento di cui non si sa niente.
Alzandomi - o svegliandomi soltanto per rialzare il capo accucciato
tra le braccia poggiate sul tavolino di studio, dove campeggiava
aperto un libro che mi aveva sfinit o fino all'addormentameto
e su cui, all'albeggiare, avevo poggiato la tempia - trovai, poggiato
di lato, lo "Zabaione della Mamma" . Pensare che era
l'estremo modo che ha una mamma di trarti ancora a sè,
di strapparti di mano questo primo vero amaro calice che la vita
ti poneva davanti e, sostituirlo, nottetempo, col bicchiere di
zabaione d'uova fresche, di Marsala - un goccio - e di cucchiaiate
colme di zucchero , agitando e strapazzando il tutto a più
di centoventi giri di polso al minuto. Pensare questo era ancora
poco. Per ravvivarmi per davvero non mi bastava più il
pur dolce amore materno e neppure il dolcissimo , nauseabondo
incollaticcio intruglio che pure tracannavo d'un sorso leccando
con la lingua i bordi del bicchiere. Mi serviva qualcos'altro
! Ecco, un sogno diverso! Lui, a me che ormai disperavo, arrivò
a ridosso del giorno epocale. E arrivò guascone e irriverente.
Proprio come il sogno che avevo sempre sognato di sognare. Vedevo
l'aula allungata a dismisura fino a sembrare la prospettiva dei
Campi Elisi, ma inframmezzata dalla lunga teoria dei banchi di
formica color verde erba rada, bordati di color nero calamaio.
Li avevano affilati alla men peggio svogliati bidelli e bidelle
giugnini, catturati prima di poter presentare il salvifico certificato
medico. Il luogo della mattanza non mi sembrava poi così
tetro . Era pur sempre il corridoio d'un austero convitto umbertino
, ma dalle vetrate in alto il sole dell'estate che fuori già
impazzava, non s'era poi proprio dimenticato di lui e di noi.
Tutto era pronto e nulla era pronto per la prima giornata. La
parvenza di ordine che regnava tra i banchi si scomponeva procedendo
ed arrivando al fondo del corridoio. Lì, qualcuno bene
informato, aveva fatto sapere confidenzialmente che il corpo insegnante-esaminante
bivaccava da almeno tre giorni . Aveva requisito oltre alla Sala
dei Professori e la Presidenza tre aule attigue e due bagni. Confortato
da questa caduta di stile e di austerità che, mano a mano
che proseguivo verso il fondo, mi si appalesava, decisi di farmelo
tutto il bagno di ardimento. Mi accostai ad Alcesti, esemplare
puro della ruffianità dei bidelli, che sotto il camice
nero da lavoro esibiva un bermuda di sgargiante "orange"
e lasciava apparire i nudi polpacci di flemmatico spostatore di
sedie e di banchi. Stava fingendo di far pulizia razzolando a
spizzichi il grosso dei resti di un qualcosa che doveva essere
nata come frugale colazione di lavoro e doveva essere in qualche
modo degenerata in un happening di selvaggia e suina colazione
sul prato ; una consumazione frenetica dopo rapina ad una tavola
calda od il kamasutra della ristorazione mordi e fuggi. C'era
di tutto : tozzi di panino indurito su cui si poteva ancora scorgere
il calco della dentatura ed affianco ostiali fette di salame tipo
Milano sgualcite ed irrancidite, patacche di olio sulle sedie
, sui tavoli finanche sul pavimenti e sui muri, vestigia di monconi
di bucatini col sugo alla amatriciana con attorno una semenza
sparsa di tocchetti di pancetta e mucillagine di pomodoro, straboccati
da una delle tante argentee vaschette di carta d'alluminio e carta
oleata. E fazzoletti di carta e da naso e d'altro tipo, di risulta
o d'emergenza, smusati e snasati e strofinati in ogni altra parte
del corpo; un collage di assaggi di ortaggi smozzicati e scorze
di anguria sugate sino al più pallido rosa e mordicchiate
anche sui lati con l'avidità del teschio di Ugolino, e
semi e noccioli di pesca e piccioli e torsoli di pera. Di carne
,quella vera, neanche l'ombra, tantomeno l'osso. Di pesce, quello
fresco, neanche l'odore di risulta. Solo sette od otto lische
inconfondibili di sarda. E poi , rovesciate per terra e ammaccate,
una variopinta cocciglia di lattine di birra,di coca cola , di
succhi di pompelmo e contenitori di cartone plastificato da cui
uscivano ancora lingue di un bianchetto dall' odore acidulo. Per
non dire dell'innumerevole quantità di cicche di sigaretta
spente e trucidate con rabbia dovunque: per terra , nei bicchieri
di carta, sotto il ripiano dei banchi di faccia contro i muri
dell'austero . Fumate portate fino alla fine, al filtro ....
La maturità a 42 anni
di Arancia
Fare
la maturità a 42 anni ha lo stesso senso di irrealtà
di un sogno bislacco. Per nove mesi, per nove mesi sono andata
ogni sera a sedermi in un’aula scolastica, proprio un’aula
scolastica, come quelle di allora. Con i banchi (ma chi li ha
inventati quei banchi?) scomodi, rotti, traballanti, la cattedra
(ma perché gli insegnanti hanno diritto ad una sedia comoda
e io che ho lavorato tutto il giorno no?), con la lavagna, il
gesso e la cartina appesa alla parete. Arrivando trafelata, dal
lavoro, salendo con un po’ di fiatone, i due piani a piedi
sotto il peso dello zaino pieno di libri. Passando bruscamente
dal mio ruolo da …"adulta", che fa un lavoro in
cui dice agli altri cosa devono fare, ad un posto dove persone,
a volte anche più giovani di me, mi danno con nonchalance
del tu, mi giudicano, e mettono in atto i loro giochini di potere.
Perché la scuola è piena di abusi di potere. La
scuola è carica di sadismo.
Lì, seduta nel banco, completamente spogliata dal mio vestito
da donna adulta. Lì, a sentirmi dire che … non si
può chiedere di andare in bagno alla prima ora, potevo
farla a casa!!! (Casa? Ma l’ho lasciata 12 ore fa). Ma vi
ci immaginate a chiedere il permesso per fare la pipì?
E poi i miei compagni, quasi tutti sotto i vent’anni, che
non sanno bene come trattarmi. E nemmeno io so come trattare loro.
Il tentativo ridicolo di mimetizzarmi che va a rotoli quotidianamente.
Nove mesi sono lunghi, in nove mesi succedono un sacco di cose.
Fuori, nella vita, non dentro alla classe. E le presenze che avevo
intorno quando ho incominciato sono evaporate. Adesso ci sono
altre presenze, per lo più emerse casualmente da un passato
troppo lontano. E che non sanno perché mi sono presa questa
gatta da pelare e cosa questo rappresenti per me. Anche se provo
a spiegarlo, non lo sanno, non hanno le coordinate per capire.
E quei ragazzi intorno che non sanno perché sono lì
e vorrebbero disperatamente essere altrove, invece per me è
quasi una questione di vita o di morte. Perché questo stupido
esame (di maturità! Ma non ho già dimostrato di
essere matura? Questo giovane uomo che ho cresciuto, che entra
e esce dalla mia casa, che inizia a costruirsi la sua vita, non
mi dice ogni giorno che sono matura?) per me significa permettere,
finalmente, che il tempo ricominci a scorrere.
Il tempo, che si era cristallizzato in un fallimento, il tempo
che si era congelato in una sorta di attesa, attesa che la vita
ricominciasse a scorrere. Attesa di sentirmi viva, di sentirmi
dentro alle cose. Questo bollino, questa certificazione, omologazione
di cultura "media", è stupidamente necessario
perché io possa scegliere di vivere. E’ un chiudere
i conti con il passato. E’ un ponte. E’ una soglia.
E’ una porta che si apre verso la possibilità di
costruire, anche se con vent’anni di ritardo, ma mia vita.
La mia, vissuta in prima persona, scelta, costruita, sudata. Non
una vita che mi vive, non un lavoro in cui arranco tirando la
pensione. E’ presuntuoso? Sì, qualcuno ha detto che
è presuntuoso. Forse. Ma io ci devo provare e, sinceramente,
ho più paura di quello che succederà dopo che dell’esame.
Per tanti motivi. Perché quando prendi la tua vita e la
rivolti come un calzino, nulla resta fermo. Ci sono cose note
ed amate che scompaiono, cose che mai avresti voluto vedere che
emergono con forza. Cambia tutto. Lo so, ho rivoltato la mia vita
come un calzino tante volte, ma mai così profondamente.
E adesso mi aspetta un futuro che devo affrontare da sola, non
perché mi serva la solitudine, ne farei volentieri a meno,
è della libertà che ho bisogno. E per la libertà
sono disposta a rinunciare al sostegno che dà il fatto
di non essere soli. Anche se, a volte, mi sento fragile.
A
un angelo
di PIkkina
Ora
dormi. Il tuo corpo di antilope, lungo, affusolato, magro, ha
il peso del sonno, il colore del bronzo nella luce rossastra di
una lampada di sale. Aderisco a te riempiendo di me ogni ansa,
ogni curva della tua schiena nervosa. Gioco con le labbra sulla
tua nuca, compiacendomi della loro morbidezza, assaporandoti.
Annuso la tua pelle tesa, liscia, il tuo odore di animale forte.
Seguo con le dita il percorso delle vene sulle tue braccia, sulle
spalle. Sono ancora gonfie. Gonfie della nostra pazzia.
Povero angelo.
Tradito dalle fattezze di uomo. Tradito dal corpo di uomo. Sento
sotto i miei seni le piaghe ancora aperte sulla tua schiena. Ti
ho strappato vie le ali, giacciono a terra insanguinate insieme
ai miei vestiti a brandelli. Povero angelo. Venuto nel mondo per
ordine di Dio, senza sapere... venuto a proteggere i deboli...
non eri preparato a me.
Può
un angelo maledire qualcosa? Se può farlo tu avrai certamente
maledetto gli istinti del tuo essere uomo. Io li ho invocati.
Conosco ogni tentazione. Sono tutte mie figlie. Le tengo in grembo
e le dò alla luce ogni volta che ne ho voglia. Che errore
darti quel corpo! Un corpo da guerriero, un masai bianco, una
virilità selvaggia e possente. Povero angelo, prigioniero
di un corpo da peccato. Non potevi sfuggirmi. Non ti avrei lasciato
fuggire. Ho seguito il tuo odore, ho imbrigliato il tuo cuore.
E conquistato il tuo corpo.
Ti ho gettato
negli abissi del piacere più sacrilego, un gradino ancora
sotto all'uomo, per la diabolica soddisfazione di degradarti più
di quanto sarebbe stato necessario.
E' stato esaltante
vederti soccombere. Peccato solo che sia stato fin troppo facile.
Non hai armi, novellino, per combattere le alchimie impazzite
di un corpo che da millenni cerca di perfezionarsi, di controllarsi.
E tu dormi?
Incosciente! Pazzo! Ho rovinato la tua missione, ti ho reso mortale,
ho lasciato in te un segno indelebile che mai troverà il
Suo perdono! Eppure tu dormi, stupido! Sembrerebbe il sonno del
giusto. Credi forse di aver scelto? Io ho scelto, io ti ho portato
con me tuo malgrado. Povero ingenuo. Credi che al tuo risveglio
potrai ancora volare? Non lo senti il dolore?
Maledetto,
stai solo tentando un'estrema difesa. Vuoi rendermi folle? Vuoi
vincere laddove non ho mai perso non una guerra, ma neanche una
battaglia?
Prova a dormire
ora che le mie unghie affilate penetrano nella tua carne viva!
Non senti nulla? Maledizione svegliati! Voglio vedere i tuoi occhi,
quell'unico pezzetto di cielo che ancora rimane in te, angelo
indemoniato! Girati! Voglio sentire ancora le tue labbra sulla
mia pelle, devo capire se sono viva...
Ma tu no,
non ti svegli. Giri lentamente il tuo corpo nudo, mi circondi
con un braccio.
Non avevo
mai perso.
Ma
ora sono prigioniera.
La
sposa è bellissima. Come tutte le spose nel giorno in cui
la vita le fa protagoniste. Meno male che ormai ai matrimoni non
mi commuovo più né m'immalinconisco. E poi a dire
il vero questo è un matrimonio allegro, affollato di giovani
coppie che prendono affettuosamente in giro i novelli sposi. Sul
sagrato della chiesa di S. Orsola li hanno tempestati con getti
di riso pasta e petali di rose. Dicono che porti fortuna. Il prete
era giovanissimo e imbranato, ha dichiarato che quello era il
suo "secondo matrimonio" senza aggiungere "che
celebrava", così ha fatto sorridere tutti perché
sembrava che il primo lo avesse sciolto con un divorzio. Oltre
la vetrata Erice è tutta una nebbia. Sono scomparse le
isole, le saline, le pinete, solo una coltre di fumo che cancella
lo sfolgorio di maggio. Allungo lo sguardo cercando di trovare
un piccolo strappo in quella cortina . Come se fosse possibile.
Il vento che arriva dal nord ha accumulato le nubi in una spessa
tela, un velario che pudicamente nasconde le splendide nudità
di una regina. "Ciao, non mi riconosci?"
Lunga pausa di incertezza di fronte alla signora in tailler-pantaloni
rosa
fragola.
"No, mi spiace, chi sei?"
Il viso mi è vagamente noto, forse l'ho incontrata da qualche
parte.
"Ci siamo incontrate al matrimonio di Antonio"
Sì, forse, anzi certamente. Ma sono passatiŠquanti
anni? Dodici, tredici?
"Scusami, non ricordo"
Lei sorride e scopre la dentatura irregolare, gli occhi sono due
buchetti
dietro gli occhiali.
"Istituto Santa Caterina, stesso banco"
"Ernesta!"
Adesso ride. Sì, Ernesta, la prima della classe prima che
arrivassi io. Dopo ci siamo divise equamente la benevolenza dei
professori. Dopotutto non è cambiata molto. Le trecce di
un biondo sbiadito sono diventate un corto castano scuro, i denti
sono quelli di allora, un po' storti, gli incisivi accavallati,
anche allora portava spesse lenti da miope. Però adesso
ha una bella figura, slanciata, elegante, ai lobi due grosse perle
le illuminano il viso.
"Ho sempre desiderato incontrare qualcuno dei compagni di
allora- dico- ma non è mai successo. Per me quello è
stato un anno importante"
"Non ho più incontrato nessuno neanche io. Dispersi,
inghiottiti dal tempo"
"Fai la farmacista mi pare"
"No, sono medico, ma lavoro in un laboratorio di analisi"
Già, era sua madre la farmacista. Il nonno era uno scrittore
noto di cui lei si vantava. Lo incontravamo nelle letture antologiche
ed io un po' la invidiavo per questa ascendenza letteraria.
"Tu,invece?"
"Io mi sono dedicata alla scrittura, qualche libro, un po'
di attività giornalistica"
"La tua famiglia?" chiedo.
"Sono sola, con i miei gatti"
"Sola anch'io, con le mie poesie"
Ci distrae il taglio della torta. Applaudiamo anche noi, con il
sorriso di circostanza e ci avviciniamo agli sposi per il brindisi
augurale. Le coppe di cristallo tintinnano urtandosi leggermente.
La sposa adesso mostra un po' di stanchezza. Il volto che al mattino
il trucco rendeva levigato si è
appannato, lo sguardo si è fatto meno luminoso, il piccolo
chignon dietro la nuca lascia sfuggire qualche ciocca scomposta.
Ora che gli invitati sciamano verso l'uscita lei si è lasciata
cadere su una sedia e distende le gambe. Il bell'abito ha l'orlo
dello strascico bordato di nero per tutta la polvere e
lo sporco che ha raccolto.
"Bella, Barbara", dice Ernesta.
"Sì, davvero, una giovane principessa"
"Al prossimo incontro"
"Sì, speriamo presto"
Ci salutiamo con due baci sulle guance. Lei ritorna ai suoi gatti,
io alle mie poesie. L'istituto Santa Caterina è un fantasma
come quelli che i miei compagni dicevano l'abitassero; è
ritornato nel buio e nel silenzio,come quando aspettavo, sola
nell'aula vuota, che mio padre venisse a prendermi.
Il
potere di John Wilkinsons
di Fargo
Non
tutti i giorni sono uguali. John Wilkinsons se ne accorse la mattina
del 14 luglio 1954, quando un raggio di luce attraversò
la lente di ingrandimento che stava sul tavolinetto, non lontano
dal letto, e si mise a fuoco sulla pianta del suo piede destro.
Nel risvegliarsi di soprassalto, l'uomo ebbe un movimento inconsulto,
picchiò la testa contro la libreria sovrastante e lanciò
un'imprecazione. Un'altra più tonante ne lanciò
quando si accorse che la pianta del piede era segnata da una piccola
ma profonda ferita. Com'era possibile? Si guardò intorno,
cercando una spiegazione che non riusciva a trovare, senza accorgersi
del sangue che gli stava colando dalla fronte.
Neanche fosse
stato chiamato per nome, John si girò in direzione del
tavolinetto: la lente di ingrandimento, lo strumento di cui si
serviva per guardare i francobolli, dichiarò candidamente
la sua colpa. Lo stupore divenne consapevolezza, quindi rabbia.
Con mossa fulminea afferrò la scatoletta di legno dentro
cui lente era imperniata e la scagliò contro il muro. Il
furore dell'uomo si placò soltanto quando la scatola andò
in mille pezzi. John entrò quindi in cucina e si sciacquò
il viso nel lavello.
- Cristo,
quanto sangue! - bofonchiò incredulo.
Tentò
di tamponare l'emorragia con un canovaccio, ma soltanto dopo qualche
minuto riuscì nell'impresa. Aprì allora lo sportello
del freezer.
- Da qualche
tempo a questa parte non me ne va bene una! - sibilò fra
i denti. L'uomo prese un cubetto dalla vaschetta del ghiaccio
e cominciò a strofinarlo sulla pelle ustionata nel vano
tentativo di attenuare il dolore persistente della bruciatura.
Stava vivendo
un altro momento di contrarietà John Wilkinsons. Si aggiungeva
ai tanti vissuti nella sua non esaltante esistenza. Scapolo 45enne,
abitava in un appartamento del West End di Londra. Non aveva parenti,
né amici, né una compagna con cui dividere una vita
che diventava sempre più angosciosa. Neanche il lavoro
lo gratificava. Era un impiegato della Morgan & Freeman Bank
senza prospettive di carriera perché, come diceva il rapporto
del direttore Miller, aveva dimostrato di essere 'un elemento
privo del necessario spirito aziendale'. Dopo che fu confinato
fra i reietti, John sprofondò nella depressione: chi può
rassegnarsi a dover fare per sempre quello che si è sempre
fatto? Per risolvere in maniera radicale i suoi problemi il suicidio
sembrava il rimedio migliore. Ma trovare il modo più conveniente
per andarsene da questo mondo non era cosa facile. Almeno per
lui.
- Roba da
non credere! - esclamò mentre sistemava un cerotto sulla
profonda ferita che si era aperta in fronte.
Frastornato
com'era, pensò che sarebbe stato meglio andare a prendere
un po' d'aria. Così, senza nemmeno fare colazione, si vestì
e uscì. S'avviò con passo incerto sulla Half Moon,
la stretta via che muore incrociando Piccadilly Street, e affondò
il viso nella frizzante aria del mattino.
- Il freddo
non potrà che farmi bene... almeno lo spero! - si augurò.
Sollevò
il bavero del cappotto. Dopo qualche passo però, la debolezza
gli fece piegare le gambe. Perse anche lucidità e non gli
riuscì di mettere a fuoco quell'unico pensiero che faceva
la spola nella sua mente: l'incidente era stato voluto da qualche
forza misteriosa?
- Non può
essere che la sfortuna! - concluse dopo una breve riflessione.
- Chi altri mai può provare interesse per me?
Preferì
pensare ad altro. Due giovani stavano venendogli incontro. Quando
furono a non più di due, tre metri di distanza, ne udì
distintamente i discorsi. «Paul, mi hai stancato. Oggi ti
mollo!» - sentì dire alla ragazza seria e accigliata.
Ascoltò quindi con molta meraviglia la risposta dello sbarbatello
che l'accompagnava. «Come finirà fra il Chelsea e
l'Arsenal stasera?».
- Cristo!
- esclamò, senza capacitarsene, John, che con la nuova
gioventù non riusciva a trovare punti in comune. - Quella
sta per scaricarlo e lui pensa al football?
Nelle vicinanze
di Piccadilly Circus avvertì un fortissimo mal di capo.
- Quell'urto
non mi avrà mica causato un danno? - si domandò
preoccupato. D'istinto si toccò il punto dolente della
fronte.
Quando si
accorse che tutti i passanti parlavano a voce alta, tanto che
lui poteva udirne distintamente i discorsi, si convinse che il
cervello non funzionava più come doveva.
- O sono io
che vaneggio, oppure i miei concittadini sono impazziti. - concluse
meravigliato. - Dov'è finito il tradizionale riserbo londinese?
Una figura
femminile lo distrasse dalle sue perplessità. Era una ragazza
dai capelli fulvi. Bella e imponente. Nel momento in cui la incrociò,
sentì nette e distinte queste parole: «Non sei niente
male!»
John si guardò
intorno per vedere se per caso lei non stesse rivolgendo a qualcun
altro la propria attenzione, ma... non c'era nessuno nel raggio
di venti metri. E allora cos'altro doveva pensare se non che fosse
diretto proprio a lui quel complimento? Esitò un attimo
prima di ritornare sui suoi passi e raggiungere la ragazza. Senza
sapere perché l'afferrò con decisione per un braccio.
- Abito non
molto distante da qui... - le sussurrò con voce morbida
- se vuoi tenermi compagnia, io...
Non ebbe il
tempo di terminare la frase perché quella gli mollò
uno schiaffo in pieno viso.
- Toglimi
le mani di dosso, - urlò inviperita. - prima che chiami
la polizia!
Del tutto
basito, John abbandonò la presa. Con rammarico vide la
ragazza scivolar via fra i passanti che avevano assistito alla
scena e gli stavano ora lanciando sguardi di fuoco e anche qualche
epiteto poco gentile. Si accarezzò a lungo la guancia dolente,
mentre, fermo sul marciapiede, tentava di dare spiegazione a una
realtà che non riusciva a decifrare. Ricacciò dentro
di sé il pensiero che da qualche istante lo irretiva: era
talmente assurdo da non meritare alcun credito. Ma, fra i tanti,
sembrava il più azzeccato.
Si rendeva
necessaria una conferma e si industriò per trovarla. Scese
nel sottopassaggio di Piccadilly Circus e seguì per qualche
minuto una coppia di anziani. Quando sbucò sulla Shaftsbury
Avenue aveva stampato sul viso il sorriso del trionfatore.
Dopo aver
ripercorso una ad una tutte le tappe di quella strana mattinata,
la conclusione cui arrivò fu una: era in grado di 'sentire'
i pensieri degli altri! Ora gli era perfettamente chiaro che aveva
'letto' e non 'ascoltato' i pensieri di tutti i passanti incontrati
sulla Piccadilly Street. Anche quello della ragazza che lo aveva
schiaffeggiato era stato soltanto un pensiero. Un inconfessabile
pensiero. Uno di quelli che, di norma, nascono e muoiono dentro
di noi senza mai uscire allo scoperto.
La rivelazione
innalzò al paradiso John che si sentì un predestinato.
«Se la scelta del caso è caduta su me», disse
fra sé «è segno che io debba compiere qualche
gesto memorabile!
Senza che
lo volesse, un profondo sospiro gli gonfiò il petto. «Ora
non sono più un signor nessuno!» - aggiunse con orgoglio
e anche un pizzico di smarrimento perché il fatto lo spaventava.
«Non sono più uno dei tanti perché nessuno
ha quello che ho io... io... io sono unico...»
Quel potere
straordinario che aveva lo portò a guardarsi intorno con
aria di superiorità.
- Chiunque
sarà soggetto a me... anche l'uomo più potente...
- fu questa la conclusione cui arrivò.
Il suo viso
assunse un'aria luciferina.
- E io potrò
approfittarne... e... potrò fare schiavo chiunque!
Con questa
convinzione salì sulla cima del mondo e si proclamò
re.
Lunedì
mattina tornò in ufficio con il piglio del guascone. Salutò
a fronte alta Miller, il direttore dell'agenzia, riservandogli
anche un sorriso, cosa che non faceva da anni. Il superiore lo
guardò stupito. «Ha bevuto o ha vinto alla lotteria,
Wilkinsons?» Questo fu il primo pensiero che gli venne in
mente nel vederlo così su di giri. Il secondo fu qualcosa
che John percepì con amarezza. Miller infatti aggiunse:
«Razza di fallito che non sei altro!»
Il malcapitato
John, ora che si sentiva alto e forte come un gigante, fu preso
dalla voglia di cantargliene quattro, ma aveva deciso di non rivelare
a nessuno il suo potere, a meno di non trarne un grande vantaggio.
Così represse l'istinto di sfogare il risentimento che
aveva accumulato per anni contro il direttore e andò verso
il corridoio che lo portava all'ufficio, sforzandosi di pensare
ad altro.
Ma il peggio
doveva ancora venire. Nei giorni seguenti venne a galla una triste
realtà: scoprì di essere sopportato. Peggio, compatito.
Quasi tutti in agenzia lo consideravano poco più di un
fallito. In verità l'idea lo aveva sfiorato, ma aveva sempre
preferito pensare che fosse una fissazione più che una
realtà. I fatti dimostravano invece il contrario. John
mal digerì la faccenda e si augurò che l'occasione
giusta per dimostrare il suo valore si presentasse al più
presto. E quella arrivò appena il giorno dopo.
Per andare
all'ufficio, John era obbligato a transitare davanti alla cassa
centrale. Lì Jack Stuart Bolton, un piccolo uomo dall'aria
mite, stava smazzando banconote.
- Come ci
si sente a pochi giorni dal ritiro? - gli domandò, felice
per lui che proprio il venerdì di quella settimana avrebbe
lasciato il lavoro.
- Bah... è una settimana come tutte le altre... - rispose
candido il cassiere.
- Come tutte le altre? Fossi al tuo posto farei salti alti fino
al soffitto... e avrei già prenotato un volo per Rio.
- Ci andrò, ci andrò... non dubitare... - rispose
quello, sorridendo sotto i baffi.
John stava
per entrare nella sua stanza quando i pensieri dell'ometto lo
inchiodarono sul posto.
«Festeggerò la fine con i fuochi d'artificio...»
- pensò Stuart Bolton.
«Nessuno sospetterà di me e io potrò portare
a compimento il piano senza correre il minimo rischio...»
John ritornò sui suoi passi mantenendosi a poca distanza
dall'uomo. Lo vide accarezzare la borsa di pelle che teneva sul
piano di lavoro. «Chi potrà mai sospettare che qua
dentro avrò messo un capitale?» Il cassiere aprì
la borsa e vi guardò dentro. «Ne entreranno abbastanza...
oh, sì... anche se saranno solo banconote da dieci e da
venti... l'avidità è una cattiva consigliera...
troppa gente è finita in galera perché non ha saputo
accontentarsi... ma io no!»
L'uomo richiuse
la borsa. John continuò a succhiare con avidità
i suoi pensieri. «Qua dentro finiranno non meno di 81.000
dollari... beh... c'è di che fare vita spensierata per
i restanti giorni.»
Il cassiere
tirò un sospiro e prese a guardare il soffitto che era
diventato più azzurro del cielo dei tropici. Tamburellò
a lungo sulla borsa mentre si impiastricciava la bocca e la mente
del miele che colava dalla sua fantasia eccitata. Si accese una
sigaretta e tirò una boccata.
«Venerdì
sera prenderò un volo per Rio... proprio come ha suggerito
quel mentecatto di Wilkinsons e scomparirò per sempre...
e poi... anche se dovessero ritrovarmi non potranno farmi nulla...
in Brasile non c'è l'estradizione per questo tipo di reato...
e io avrò tutto il tempo di rifarmi una vita...»
Sorrise amaro. «...anche se purtroppo non sarà abbastanza
lunga...»
John ebbe
un sussulto. Più del mentecatto con cui era stato bollato
da Stuart Bolton fu colpito dal piano che quello aveva architettato.
«Forse il momento che aspettavo è arrivato!»
mormorò fra se, dubbioso.
Rifletté
sul da farsi per qualche istante.
- Sì
che lo è, perdio! - disse picchiando deciso il pugno di
una mano nel palmo dell'altra. - Denunciando il furto del cassiere
disonesto, potrò riacquistare la credibilità perduta
e di sicuro me ne tornerà un vantaggio!
Il vecchio
cassiere inseguì un altro flusso di pensieri e John gli
corse dietro.
«Riempirò
la borsa dopo che tutti se ne saranno andati ... e poi prenderò
il mio aereo... ci metteranno del tempo lunedì mattina
per capire quello che è successo...» Scoppiò
in una grassa risata. «Vorrei essere qui e vedere la faccia
di Miller quando capirà che 81.000 angioletti hanno lasciato
per sempre la banca...»
Stavolta a
ridere fu John. La folle idea del cassiere della Morgan &
Freeman Bank, arrivava a proposito.
Senza perdere
tempo, bussò alla porta di Miller. Salutò con deferenza
sia il superiore che Ann, la segretaria. Il direttore si stupì
nel vedere Wilkinsons dietro alla porta del suo ufficio: non era
cosa che usasse fare spesso di sua iniziativa. Curioso di sentire
quello che aveva da dirgli, si sforzò di essere cortese.
- In cosa
posso esserti utile, caro Wilkinsons?
Quel caro
suonava falso un miglio, ma John fece finta di nulla e si accomodò
in poltrona. A Miller sfuggì un «razza d'incapace!».
Naturalmente fu un pensiero il suo. Ma quel pensiero arrivò
dritto alla mente di John, e lui faticò non poco a far
cadere l'offesa nel nulla.
«E'
velenoso come uno scorpione, il caro direttore.» - rifletté,
mentre diventava sempre più manifesta la scarsa considerazione
di cui lui godeva. «Ma fra un po' dovrà ricredersi.»
Miller tese a John una scatola di sigari Avana.
- Ne gradisci uno? - domandò premuroso.
Wilkinsons ne prese uno.
- Dimmi pure quello che hai da dire. - lo sollecitò il
direttore.
- Uhm... vede, capo... non è per niente facile... ecco...
beh... sono al corrente di un furto che venerdì sera verrà
perpetrato nella nostra filiale.
Il sorrisetto
di Miller svanì di colpo. Una boccata di fumo gli andò
di traverso e cominciò a tossire come un dannato. John
osservò divertito la scena, ma si augurò che il
capo non si strozzasse proprio ora che era arrivato il momento
di prendersi una clamorosa rivincita.
- Un furto?
E da parte di chi?
- Di un impiegato di questa agenzia.
Sul volto del direttore si disegnò una smorfia di scetticismo.
- Non ci posso credere. Qua dentro c'è soltanto gente fidata.
- Anche troppo, se è vero che la persona in questione conta
su questa fiducia per portare a termine il piano che ha preparato!
Miller aspirò un'altra boccata di fumo. Cercava in tutti
i modi di mantenere la calma.
- Hai una strana aria di trionfo, Wilkinsons... - riprese a dire
con voce morbida. - che mi insospettisce un po'... non è
che per caso mi stai tirando un colpo mancino?
- Assolutamente no! É la pura verità.
John cercò di essere convincente per quanto poteva.
- Che prove hai per dimostrarmi che non è una fantasia
la tua?
- Non ho prove...
- Volevo ben dire!
- ... ma ho la certezza che quel furto avverrà.
- Senti, Wilkinsons... se c'è una cosa che non tollero
è quella di essere preso in giro!
Miller si alzò in piedi di scatto e picchiò il pugno
sul tavolo.
- Quella che mi stai raccontando è una cosa senza senso!
John non si scompose. Fece la sua replica con aria sottomessa.
- Non si scaldi, capo... vuole le prove?
- Sì che le voglio! Che aspetti?
Vista l'impazienza di Miller, John si affrettò a svelare
il suo segreto.
- Bene... l'avverto però che rimarrà sorpreso...
eh, sì... dunque... io.... io... ho il potere di leggere
nella mente degli altri.
A quella dichiarazione
il direttore scoppiò a ridere.
- Ho sempre
detto che hai qualche rotella fuori posto, Wilkinsons, e a quanto
pare non mi sono affatto sbagliato!
John si alzò
dalla poltrona, puntò i pugni sul tavolo, avvicinò
la testa a quella di Miller e lo fissò con occhi di ghiaccio.
- Vuole mettermi
alla prova, caro direttore?
John calcò
la voce di proposito sul caro. Ormai non temeva più né
lui né altri.
- Certo che sì. Ma come?
- Sarà presto detto.
John non impiegò molto tempo a dimostrare la facoltà
che aveva acquisito. Il direttore e la segretaria, dopo le infinite
prove cui lo sottoposero, finirono col rimanere senza parole.
Ann cominciò a temerlo perché si sentiva del tutto
indifesa contro quel potere che la espropriava della sua intimità.
«Nessun essere umano può frenare un pensiero»
- fu la conclusione a cui la donna giunse con grave imbarazzo.
«neppure se riprovevole...».
John colse
le difficoltà di Miller e della segretaria. Ne gioì.
«Eh eh eh... » - disse ridendo fra sé. «
li tengo in pugno... proprio come pensavo.»
Il direttore
non si preoccupò più di tanto del potere di John.
Quello che a lui premeva in quel momento era conoscere i particolari
del furto annunciato. E John rivelò i pensieri di Stuart
Bolton. Saputo quanto frullava nella testa del cassiere, Miller
montò su tutte le furie.
- Chi l'avrebbe
mai detto? L'uomo più fidato dell'agenzia vuole mettermi
nei guai! Maledetto! Essere raggirato da chi gode la mia stima
è cosa disgustosa... qua dentro tutto funziona sulla fiducia...
se avvenisse un furto del genere, i proprietari della Banca non
ci penserebbero due volte a prendermi a calci nel sedere... ma,
grazie al tuo aiuto, Wilkinsons, io potrò venirne fuori
con successo... tutti ne verremo fuori con successo... sicuro...
anche tu.
Miller abbracciò
il dipendente.
- Dobbiamo
festeggiare! - esclamò il direttore andando verso il piccolo
frigorifero che teneva accanto alla scrivania.
Prese una
bottiglia di champagne e la stappò. Contravvenendo all'etichetta,
offrì il primo bicchiere a John.
- Tieni, te
lo sei proprio meritato. Sarà ovvio quanto dico, ma la
mia gratitudine non si esaurirà con un bicchiere di champagne,
seppur ottimo.
La tua posizione
in seno a questa agenzia verrà riconsiderata, caro Wilkinsons.
Diventerai il mio vice appena quel traditore di Stuart Bolton
sarà arrestato.
Il direttore
levò in alto il bicchiere e altrettanto fecero la segretaria
e John. Questi assaporò il momento del trionfo con molta
compostezza, anche se si sentiva frizzante come le bollicine che
vedeva scoppiare nel bicchiere.
D'accordo
con l'ispettore Perkins, del vicino commissariato di Mayfair,
fu preparato un articolato piano per l'arresto del ladro. La banca
sarebbe stata tenuta sotto osservazione già da mercoledì.
Venerdì sera un nugolo di poliziotti in borghese sarebbe
stato sguinzagliato lungo le vie che correvano intorno all'isolato
della Morgan & Freeman Bank, così da chiudere qualsiasi
via di fuga al malfattore e ad eventuali suoi complici. Stuart
Bolton sarebbe stato bloccato non appena avesse messo piede fuori
dell'edificio.
Nei giorni
che precedettero l'evento, Miller spiò le mosse del cassiere
con molta discrezione. Ebbe la conferma che l'uomo stava tramando
qualcosa, quando questi, contrariamente alle aspettative, lo informò
che avrebbe offerto il rinfresco d'addio giovedì pomeriggio
e non venerdì. Il motivo che lui indicò per giustificare
l'anticipo fu che aveva prenotato un volo per una località
lontana - di cui non rivelò il nome - e che non poteva
ritardare nemmeno di un minuto l'uscita dalla banca, dato che
a quell'ora la strada per l'aeroporto di Heathrow era sempre molto
affollata. Miller, nell'ascoltare la motivazione, sorrise. Stuart
Bolton non avrebbe raggiunto nessuna località vicina o
lontana: sarebbe finito presto dietro le sbarre di una angusta
cella.
Sotto il peso
della tensione che li schiacciava, John e Miller aspettarono impazienti
che le lancette dell'orologio toccassero le 17 e 30 di Venerdì
20 luglio. All'ora della chiusura, il personale dell'agenzia abbandonò
alla spicciolata l'edificio. Solo Jack Stuart Bolton rimase a
fare, per l'ultima volta, quello che era di sua competenza. Controllò
che tutto fosse in ordine all'interno degli uffici, ispezionò
la cassaforte assicurandosi che nessuno fosse rimasto dentro,
spense la luce interna, chiuse la porta ruotando la grande maniglia
centrale, fece scattare la combinazione. S'avviò quindi
verso l'uscita e, dopo aver spento le luci in sala, chiuse dietro
di sé la massiccia porta d'ingresso. Fuori pioveva a dirotto.
Il cielo, nero come la pece, era attraversato da saette che illuminavano
a giorno tutta Londra e sfogavano rabbia repressa esplodendo con
fragore.
Quattro macchine
della polizia erano dislocate agli angoli dell'isolato, mentre
un discreto numero di poliziotti teneva d'occhio l'edificio da
diversi punti d'osservazione. John e Miller, dentro una macchina
parcheggiata a non più di trenta metri dalla banca, attendevano
l'ora X. Stuart Bolton avanzò sulla Berkeley Street cercando
un riparo che il suo striminzito ombrello non poteva dargli. Nella
mano sinistra stringeva la fedele compagna di tanti anni di lavoro,
la vecchia borsa di pelle che sembrava più gonfia del solito.
Aveva l'aria felice, almeno così sembrò a Miller
e John, quando passò davanti alla loro auto. Dopo qualche
istante, due poliziotti lo fermarono e lo costrinsero a entrare
nella macchina della polizia che, come per incanto si era materializzata
alle loro spalle. L'uomo fu portato al commissariato di Mayfair.
John e Miller, al settimo cielo per il successo dell'operazione,
dopo qualche minuto entrarono negli uffici del distretto.
Miller era
livido dalla rabbia e quando si trovò di fronte a Stuart
Bolton fu preso addirittura dalla voglia di sferrargli un pugno.
Riuscì a darsi un contegno soltanto perché si rese
conto che il 'nemico' era un vecchio uomo. Non evitò però
di apostrofarlo pesantemente.
- Vigliacco!
Così ripaghi la fiducia che ho sempre avuto in te?
Il cassiere
s'accese di rosso in viso, abbassò la testa vergognoso
e non disse una parola in sua difesa.
- Sapevamo
benissimo dove volevi portarla!
Miller alludeva
alla vecchia borsa che l'uomo teneva stretta a sé.
- Volevi andare
a Rio, eh, mentecatto? - aggiunse John con aria perfida.
Miller aveva
preso a camminare su e giù per la stanza per liberare il
nervosismo che gli impediva di stare fermo. Ritornò a bomba.
- La fiducia
di cui godevi ti ha illuso che avresti potuto farcela... non posso
darti torto... chiunque al tuo posto avrebbe pensato la stessa
cosa... ma... ma il diavolo ci ha messo lo zampino. Per fortuna
che sono venuto a conoscenza del tuo piano... altrimenti per colpa
tua avrei passato guai molto seri...
Rivelò
quindi al cassiere com'era arrivato a sapere del furto.
- Soltanto
grazie al potere straordinario di Wilkinsons il tuo piano scellerato
è stato sventato!
Miller si
fermò davanti a Stuart Bolton. Questi continuava a mantenere
la testa bassa. Si avvicinò al cassiere e scoppiò
in una risatina di scherno.
- Sei stato
preso in trappola come un topo! - gli sussurrò a voce bassa.
Il vecchio
uomo si limitò a guardarlo da sopra gli occhiali con occhi
mansueti. Miller andò verso il fondo della stanza soddisfatto:
il silenzio dell'ometto era un'esplicita ammissione di colpa.
- Può
mostrarci per cortesia... - intervenne per la prima volta l'ispettore
Perkins. - ... il contenuto della borsa?
Alla richiesta
dell'ispettore, l'imbambolato Stuart sembrò scuotersi dal
torpore che lo teneva bloccato.
- Oh, sì...
certo... ma... ma perché mi chiedete questo? - domandò
con voce flebile il cassiere.
- Non tergiversi,
per carità di Dio, e risponda! Qui le domande le faccio
io!
L'invito di
Perkins era perentorio.
- È
stato il sogno di tutta la mia vita... - rispose con tono piagnucoloso
il cassiere, stringendo ancora più forte la borsa al petto.
Miller, John
si guardarono increduli. Dopo qualche istante di angoscioso silenzio,
il vecchio uomo mise la borsa sulla scrivania dell'ispettore.
Esitò a lungo prima di aprirla. Poi fece scattare le molle
che bloccavano i fermi. I tre uomini aspettavano con impazienza
di veder saltar fuori le mazzette di dollari da 10 e da 20 dollari
che Miller doveva aver messo dentro.
Senza scomporsi
più di tanto, Stuart Bolton tirò fuori dalla borsa
pezzi di giornale, più o meno della grandezza di una banconota.
Miller incredulo strappò la borsa dalle mani del cassiere
e rovesciò a terra tutto quello che ancora conteneva. Volarono
in aria molti altri ritagli di giornale, ma... dei dollari non
v'era traccia!
Con lo sguardo
smarrito, il direttore della Morgan & Freeman Bank volò
su Perkins e Wilkinsons. Cercava aiuto. Forse i dollari erano
mescolati a quei ritagli di giornale che ora stavano un po' dovunque.
Ne raccolse da terra più che poté e li guardò
con attenzione: erano solo dei volgari pezzi di carta! Tornò
a frugare nella borsa, ma questa era desolatamente vuota. Vuota!
Al colmo della disperazione, Miller, dopo averlo afferrato per
il colletto, sollevò da terra il cassiere e lo strattonò
più volte.
- Dove hai
messo i dollari, ladro maledetto? - gli urlò.
Perkins, quando
s'avvide che Miller aveva perso il controllo di sé, intervenne
bruscamente.
- Miller!
Non posso consentirle un sopruso del genere! Le ordino di prendere
le distanze da Bolton!
La voce tonante
dell'ispettore costrinse Miller a lasciare la presa.
Stuart Bolton
scivolò a terra e, in debito d'ossigeno, fu colto da violenta
tosse. Strabuzzò gli occhi più volte prima di ritrovare,
e a fatica, il respiro. Miller, come un mastino che ha addentato
l'osso, non aveva però alcuna intenzione di mollare.
- Dove sono
i dollari che hai rubato, farabutto? - gli sibilò a non
più di dieci centimetri di distanza dal viso.
- Dollari?
Quali dollari? - ripeté quello stupito.
L'ingenua
domanda del cassiere fece lievitare ancora di più la collera
di Miller.
- Conosciamo
i tuoi piani, razza d'idiota! - urlò l'inviperito dirigente
della Morgan & Freeman Bank.
Perkins stava
per intervenire di nuovo quando il cassiere prese a parlare.
- Ho una confessione
da fare... - disse l'ometto. - ...rubare è stato il pensiero
fisso di tutta la mia vita... il mio sogno nascosto...
Nella mente
dei tre uomini cominciò ad affacciarsi il sospetto di aver
preso un colossale abbaglio.
- Con tutti
i soldi che mi sono passati per le mani... pensare di rubare è
stata cosa più che normale... chi al mio posto non l'avrebbe
fatto? ...però... da quando in qua sognare è diventato
reato?
I tre uomini
non volevano capire quanto l'uomo andava dicendo.
- Ho ritagliato
pezzi di giornale a misura di banconote e ne ho riempito la borsa...
al termine del mio ultimo giorno di lavoro volevo sentirla più
pesante che mai... è bello correre dietro alle fantasie...
anche la fuga a Rio è stato solo una magnifica fantasia...
Le affermazioni
di Stuart Bolton, come un unico, micidiale colpo al mento, ebbero
il potere di mandare i tre uomini al tappeto.
Stentò
a prendere sonno quella sera John Wilkinsons. Rifletté
a lungo sulla disgrazia che gli era capitata, perché ora
poteva, e a ragione, parlare di disgrazia: era un disoccupato.
Dopo l'insuccesso dell'impresa, Miller lo aveva licenziato in
tronco. - Nessuno può permettersi di farmi fare la figura
del fesso!
Con questa
accusa era stato rispedito a casa. Ma più del licenziamento
a preoccuparlo era ben altro. Predestinato un corno! Avere quel
potere si era rivelato un pessimo affare. Da quando ne era entrato
in possesso aveva ricavato solo guai. E poi, provava grande disagio
nel dover ascoltare i pensieri degli altri. Ogni volta che interloquiva
con qualcuno, il primo a finire sotto il riflettore era proprio
lui. Tutti, chi più chi meno, avevano qualcosa di malevolo
da rivolgergli, e se anche non erano diretti a lui i pensieri
degli altri, doveva sempre assorbire qualcosa di sgradevole, di
antipatico, e anche di criminale. Non poteva fidarsi di nessuno:
le persone più false erano quelle che passavano per affabili
e accomodanti.
Certo, il
campione di umanità che lui poteva osservare era scarsamente
significativo, ma, dopo una settimana di attenta e stupita osservazione,
nessuno avrebbe più potuto togliergli dalla mente che tutto
il mondo delle umane relazioni faceva perno sull'ipocrisia e la
bugia: la gente, purtroppo, lasciava trapelare all'esterno solo
verità di comodo. La generica conclusione cui arrivò
fu che la cattiveria del genere umano era molto più grande
di quanto avesse mai supposto.
- Tutta l'umanità
è imparentata col demonio e io... e io... purtroppo...
dovrò subire questa condanna per il resto della mia vita...
Liberarsi
di quel potere fu l'ossessione che lo tormentò nei giorni
che seguirono. Ma come avrebbe potuto? Dopo lunghi rimuginamenti,
una certezza affiorò nella sua anima: non avrebbe mai potuto!
- Non mi rimane
che farla finita! - sbottò in un momento di profonda disperazione.
Era notte
fonda quel lunedì e John, non riusciva a prendere sonno.
Volse lo sguardo alla finestrella della sua stanza e fissò
a lungo la fetta di cielo che stelle baluginanti bagnavano d'oro.
Si sentì un condannato a morte che vive la sua ultima notte.
La stanza angusta, dentro cui soltanto qualche timido raggio riusciva
a entrare, divenne una cella dalle pareti infinite. Mentre malediva
quel potere che lo aveva distrutto e fatto schiavo, John si addormentò.
Il giorno accese le luci di lì a poco. A mattina inoltrata,
un raggio di sole entrò nella stanza. Per uno strano gioco
del destino, investì la lente di ingrandimento che stava
sulla sedia in fondo al letto e, come un dardo infuocato, trafisse
la pianta del suo piede destro. Nel reagire al dolore, John si
mosse scompostamente e batté la testa contro la libreria
che stava sopra di lui. Imprecò a voce alta, mentre il
sangue colava copioso dal taglio che si era aperto sulla nuca.
Tamponò come meglio poté la ferità, si vestì
e uscì perché aveva bisogno d'aria. Mentre camminava
sulla Piccadilly Street incrociò una bella ragazza dai
capelli rossi. Quando le fu vicina, John si aspettò di
leggere i suoi pensieri, ma non gli riuscì.
- Possibile
che non abbia niente nella testa? - si chiese dubbioso. - Non
posso crederci...
Tese nuovamente
l'orecchio, ma ancora una volta, non 'sentì' nulla. Un
pensiero entrò nella sua mente a passo di carica. Smanioso
di avere un'immediata conferma, si portò a ridosso della
ragazza e quella, per timore di essersi imbattuta in un maniaco,
si impaurì.
- Allontanati
da me, razza d'imbecille! - gli urlò. - Se non vuoi che
chiami la polizia!
Mai minaccia
giunse più gradita alle orecchie di John. Zigzagando pericolosamente
fra le macchine, si portò sull'altro lato del marciapiede.
Avvicinò una persona. E poi un'altra e un'altra ancora.
Non 'sentì' nulla. Saltò dalla gioia quando capì
che la mente degli altri era diventata impenetrabile al suo potere.
Prese allora a sorridere a tutti quelli che incontrava, inchinandosi
e facendo il gesto di togliersi un cappello che non aveva.
- É
il regalo più bello che io potessi ricevere! Grazie, mio
Dio! - urlò con voce tonante, alzando mani e testa al cielo.
I passanti,
pensando di avere a che fare con uno squilibrato, presero in fretta
le distanze da lui. Cominciò a piovere. Dopo qualche minuto,
un temporale di inaudita violenza sfogò la sua violenza
sulla città. John, incurante dell'acqua gelida che si rovesciava
a terra da un cielo color catrame, rimase sul marciapiede senza
cercare riparo. Neppure il sangue che aveva macchiato il colletto
della sua bianca camicia, lo convinse a smuoversi di lì.
Ritornò a casa soltanto quando un pallido sole riuscì
a bucare una nuvola sfibrata. Lasciò che la luce gli bruciasse
gli occhi. La luce! Già, la luce aveva segnato l'inizio
e la fine della sua disgrazia. E anche illuminato il suo intelletto!
John Edward
Wilkinsons, protagonista di una vicenda ai confini della realtà,
scoppiò a piangere quando si accorse di aver ritrovato
un bene che credeva di aver perso per sempre: quello cioè
di essere un uomo come tutti gli altri. Uno dei tanti.
FINE
17 aprile
2003
Hop
di
James Globtrotter
Hop...
Olè! Centro!
Porca puttana...
Ma che devo fare? Ci sto provando, ci sto. Ma non mi viene! Ma
chi l'ha mai scritta una lettera d'amore prima d'ora...
Guardo il cestino della carta straccia, che ho sistemato nell'angolo
più lontano della stanza per aumentare la difficoltà
di tiro; è pieno di improbabili parole appallottolate,
scritte un po' su fogli a righe, un po' su fogli a quadretti.
quelle sui fogli a quadretti sono le più sfortunate, tutte
quelle righe azzurrine sembrano sbarre inamovibili poste ordinatamente
tra una vocale e una consonante, così, a trattenere in
confini geometrici ciò che tutto è, meno che geometria...
Ma che cazzo sto pensando...ci manca solo che mi metto a filosofeggiare
adesso...
Ok. ok... ricominciamo. In fondo quattro paroline dolci, in fila,
dovrei riuscire a inventarmele. Non pretenderà mica un
poema alla Prevèrt, che io più delle frasi stile
baci Perugina non sono proprio in grado di. Andavo pure male,
in italiano, a scuola.
ma che sarà
venuto in mente a giulio, di tirare fuori quella storia della
lettera d'amore che ha scritto lui a patrizia quando gli ha chiesto
di sposarlo.
l'ho vista
poi stefania come mi ha guardato...
Stefania
amore mio
secondo me
potrei anche terminarla qua 'sta lettera, che tanto al "mio"
sarà già svenuta che non è abituata... Vabbè
dai Alex, non fare lo stronzo e ricomincia a scrivere...
Stefania,
amore mio
la virgola
ce la metto dopo il nome perché fa un bell'effetto pausa,
come se la guardassi negli occhi...
stefania
pausa
amore mio
sì,
suona bene. ha un effetto ...pathos-logico. bella battuta pathos-logico,
me la devo ricordare. se mi sentisse il mio vecchio insegnante
d'italiano a fare queste considerazioni stilistiche con tutti
i quattromenomeno che mi affibbiava, gli verrebbe un colpo apoplettico
gli verrebbe. e senti che termini che utilizzo...
Stefania,
amore mio
Stasera mentre attraversavo il piazzale davanti alla Coop per
andare a comprare qualcosa per cena, ho incontrato il tramonto
più bello che io abbia mai visto da quando vivo qua, ovverossia
da quando sono nato. Sì, l'ho incontrato. Perché
lui mi è venuto incontro, e io ho rallentato il passo,
e mi sono fermato ad attenderlo. Era così vivo, così
intenso, che faceva quasi male, a guardarlo. No, non è
corretto, faceva male a guardarlo da solo. Perché tu non
c'eri. E allora ho pensato che avrei voluto che fossi tu a spingere
questo carrello nel piazzale, e io avrei camminato accanto a te
per prendere quel pacco di riso sullo scaffale troppo in alto
per te, e poi mi avresti dato un bacio-grazie e io ti avrei dato
una pacca sul sedere e tu avresti sorriso arrossendo e io avrei
capito che eri contenta, e anche la gente intorno lo avrebbe capito.
Invece
non c'eri. E io ho chiesto a quel tramonto di andare via, e di
tornare domani. Che volevo presentargli la mia futura moglie.
Tu
che ne dici? Ti va di fare le presentazioni ufficiali?
Ti amo.
Alex
wow, alex
sei un mito! sì, ho scritto proprio una bella cosa! credo.
almeno penso. però... no, un momento... forse il supermercato,
il carrello, non sono cose proprio romantiche... magari pensa
che la voglio sposare per avere chi cucina e va a fare la spesa.
che certo conta anche quello, ma non è mica per quello...
poi in effetti non ho scritto proprio grammaticalmente perfetto,
che lo scaffale dove in alto c'è il riso non sta mica nel
piazzale. magari ritocco qualcosa, taglio qualche frase troppo
lunga, il senso però non lo cambio che il tramonto che
ritorna domani mi piace...
Stefania,
amore mio
Stasera,
mentre passeggiavo, ho incontrato il tramonto più bello
che io abbia mai visto. Sì, l'ho incontrato. Perché
lui è apparso all'improvviso, o forse io ero distratto,
poi ho rallentato il passo, e mi sono fermato ad attenderlo. Era
così vivo, così intenso, che faceva quasi male,
a guardarlo. No, non è corretto, faceva male a guardarlo
da solo. Perché tu non c'eri. E allora ho chiesto a quel
tramonto di andare via, e di tornare domani. Che volevo presentargli
la mia futura moglie.
Tu
che ne dici? Ti va di fare le presentazioni ufficiali?
Ti amo.
Alex
non mi convince...
dove andavo a passeggio da solo? e poi che era? un tramonto allievo
di silvan che appare all'improvviso? anche che ho rallentato il
passo non mi piace, sembra l'esame orale per la patente... signor
mancinelli, cosa fa lei quando un tramonto le appare all'improvviso
in prossimità di un incrocio? Rallento il passo e all'occorrenza
mi fermo! boooocciato!!! ma dai...
e poi adesso
è troppo corta, io non l'ho mai vista una lettera d'amore
di sei righe più saluti...
Stefania,
amore mio
Vorrei saper usare la penna come Van Gogh usava il pennello, per
dipingere con le parole giuste, con le giuste tonalità,
le emozioni che non riesco a tradurre in linguaggio...
ma che è?
Prima dipingo, poi traduco... da alex: centro multiservizi...
mi so' un po' incartato...
Stefania,
amore mio
Non riesco a tradurre in parole tutto ciò che si agita
in fondo al mio cuore quando ti penso.
E' un mare di emozioni che mi afferra alla gola, e mi strizza
i polmoni succhiandomi via il fiato, ogni volta che te ne vai.
Mi manca, la mattina, l'impronta della tua testa sul cuscino orfano
di te. Inutile attenzione in piuma d'oca se non l'impreziosisci
del tuo sorriso, e dei tuoi capelli così sensualmente disordinati.
Che non t'ho mai detto quanto sei bella appena sveglia, con gli
occhi che si aprono piano e lo sguardo appannato, mentre inumidisci
le labbra screpolate di sogni con quella lingua piccola e puntuta
e rosa e cerchi di sistemare la camicia da notte che è
una sottoveste corta, e ti lascia sempre scoperte le gambe e anche
un po' più su. Perché non stai mai ferma, mentre
dormi. Che un seno sfugge sempre fuori da quel triangolino di
seta nera che dovrebbe celare e invece svela. Traditore. Che ogni
volta ho voglia di...
Sì,
vabbè, ecco ambrogio in versione kamasutrica... stefania,
amore mio, ho voglia di qualcosa di buono... spogliati. sembro
un maniaco, sembro... non ci riesco proprio... ma poi chi ha detto
che è obbligatorio scrivere una lettera sdolcinata per
chiedere la mano alla propria donna? lei lo sa che io non sono
un tipo romantico e melenso... anzi... adesso la vado a prendere,
le compro un mazzo di fiori, la porto a cena fuori e glielo chiedo
senza troppi giri di parole, ecco così mi sembra sicuramente
meglio... scrivo subito un biglietto d'accompagnamento per i fiori
e vado...
Stefania,
vorrei chiederti la mano.
E anche tutto il resto.
Ti consiglio di accettare altrimenti sarò costretto a rubartela,
la mano. E anche tutto il resto.
Lo sai che sono un ladro gentiluomo.
Vuoi provare tu a fare di me un uomo onesto?
Ti amo.
Tuo
Arsenio Alex Lupin
ecco, adesso
mi ci ritrovo, non sarò poetico ma... e poi sicuramente
lei scoppierà a ridere e mi guarderà scuotendo piano
la testa, inclinandola leggermente a sinistra... e magari arrossendo
un po' mentre nasconde il viso fra le mani... che a me Stefania,
quando mi guarda così...
Chi
gioca con il mondo?
di
Maria Laura Platania
Unghie,
dal gesso consumato, graffiano stridule l’asfalto.
Occhi di scoiattolo impaurito afferrano, aprono, vuotano un sacchetto
che si affloscia misurando, in sequenza, fragori antichi. Un gioco.
Chi gioca con il mondo?
Roma si sveglia pigra miagolando sui tetti morbidi. L’aurora,
l’indecisione della notte a farsi giorno, clacson di sbadigli
degli ultimi nottambuli, stridio di freni dei netturbini, il fragore
sordo delle saracinesche dei bar, l’odore forte del pane
appena sfornato confuso a quello delle brioche e del caffè
caldo.
La villa bassa e signorile immersa nel verde recita serenità
e discrezione, sin dal cancello di ferro battuto intrecciato di
glicine antico, concluso da lunghe lance rivolte verso il cielo,
la pulsantiera sul lato destro, senza nomi, né sigle, su
quello sinistro il cave canem di un boxer bonario.
Silenzio e discrezione, non fosse per quella insolita incuria
del giardino, lunghi ciuffi d’erba selvatica nelle fessure
del pavé: una villa abitata, in altro tempo.
Federico Ferroni era stato commissario di zona, fino all’anno
prima.
Prossimo a una settantina vigorosa, collaborava ancora alle indagini
di polizia, fonte inesauribile di memorie catalogate, ordinate,
ma, soprattutto, vissute come nessun computer avrebbe mai potuto.
Di un incontro, occasionale o meno, di un ricercato arrestato,
rilasciato o passato a miglior vita, lui ricordava tutto, parenti,
amici, rapporti, gusti, preferenze. Irrisolti rancori. Diceva
scherzando ai più giovani colleghi che la memoria era per
un poliziotto quello che è la corazza per una tartaruga:
permetteva un cammino, lento, ma sicuro verso la vecchiaia.
E adesso quel volto di bimba avvizzita frugava, sgraziata, la
mente, stridendo unghie di gesso.
Dall’altro lato, Villa dei Glicini. Crimini, fattacci. Chi
li ricordava più?
C’era scappato il morto.
Un ladro – s’era detto - s'era intrufolato nella villa
e sorpreso a rubare aveva strangolato la giovane domestica senza
portare via nulla. Una ridda di ipotesi, senza possibilità
di verifica, mentre si passava al setaccio ogni risvolto della
vita della famiglia che risiedeva lì da molto tempo, rispettata
e stimata dalla gente del quartiere. E così nessuno aveva
voluto credere alla storia del dottor Mariozzi, amante della servetta
diciottenne, né alla gelosia della moglie, né all'ipotesi
che la loro figlia, dai begli occhi scuri, fosse frutto di una
relazione adulterina di quel marito tanto devoto.
Ferroni, all’epoca dei fatti, un'idea se l'era fatta: Giulietta
- così si chiamava o si faceva chiamare la ragazzina venuta
da un paesino là vicino, a Roma per “abbuscarsi la
gallina”, come diceva ai negozianti dive faceva la spesa
per la “signora” - doveva essere stata l’ingenua
vittima di un sordido gioco.
Quella cassettuccia, bianca per il grezzo del legno che lasciava
la Chiesa di Sant'Agnese al Nomentano nel caldo innaturale di
un Novembre avanzato, seguita solo da un uomo troppo vecchio per
essere il padre e che si avviava mesta al cimitero di Prima Porta
era memoria viva.
Un delitto senza colpevoli, tanto fango su una ragazza che non
aveva trovato nella Roma dei suoi sogni neppure i soldi per pagarsi
il viaggio di ritorno al suo paesello.
La famiglia Mariozzi aveva finito con l’ abbandonare la
casa.
Cacciati i padroni, nella fantasia del popolo, Giulietta, con
le sue quattro ossa di contadina, aveva ripreso possesso della
Villa, libera di respirare quel profumo di glicine che rubava
nella stagione del suo fiorire.
Un caso irrisolto, una delle poche macchie nella carriera del
commissario.
Cose che pesano a settant’anni, quando resta poca sabbia
nella clessidra.
E ora ecco quella ragazzetta pallida, gli occhi affossati nelle
orbite cadaveriche, cenciosi capelli di stoppa, attraversare la
strada farglisi d’accanto, soffiando nell'orecchio l'osceno
di una proposta sibilata mostrando il rosso di una lingua trafitta
da una minuscola sfera d'acciaio.
Il vecchio commissario è turbato, sente l’acuto di
un dispiacere attraversargli lo stomaco: che ci fa per strada
una ragazzina così, all’alba, ora da ladri, da donnacce,
da vecchi insonni… quanti anni puoi avere? Quindici, sedici
a rotolare negli angoli di strada lasciando che uomini e donne
in sudicia sequenza sporchino l'ingenuità di un seno che
non ha avuto neppure il tempo di sbocciare, di gambe livide.
Quelle gambe che, adesso, aggrediscono a due, a tre la volta i
gradini alti e irregolari della villa, mentre il volto, appena
arrossato dalla fatica, si gira di tanto in tanto per assicurarsi
che l’uomo la segua.
Silenziosa e impavida indica un uscio socchiuso: la villa e il
suo interno.
Tende, moquette, lampadari, la tappezzeria, quadri, biancheria,
bagni e ottoni lucidi, asciugamani in bella mostra: tutto è
lindo, tutto è ordine.
Davvero Giulietta hai continuato, serva fedele, a custodire i
luoghi della tua esistenza?
Ora il viso di bimba senza sorriso si affaccia dolente dallo stretto
dell’uscio. Prende il sacchetto.
Giochiamo? Giochiamo insieme al gioco del mondo?
Ammaliato Ferroni, d’improvviso, comprende di chi è
quel volto.
A che serve il sacchetto, bambina di ghiaccio?
Cos’è il mio sacchetto? Ma è il mondo e dentro
striscioline di carta, gli spiriti degli dei. Ora è giunto
quel tempo, aprirò il sacchetto, ora non so più
controllare la mia disperazione. Hanno aspettato vent’anni
gli spiriti potenti, ora bisogna sollecitare il loro aiuto.
E’ freddo il muro d’ombre che narra di gente cattiva,
d’una bimba nata per odio da un ventre di serva, strappata
all’amore di mamma, allattata a veleno da sterile madre.
Follia ordina di togliere vita a chi la vita ha appena donato
e invoca, tremando, non ditelo a mio padre, non fate soffrire
mio padre.
E arriva quel padre, contadino ferito: è ombra irata e
possente nel teatro del mondo. La vede il vecchio Ferroni, perché
solo ora la vede?
Hai giocato bambina? Hai giocato bambina?
E stringe, stringe il tenero di quella carne che è la sua
carne.
Si spezza la storia, graffiata con unghie di gesso, mentre leggeri
gli spiriti placano la disperazione di un’ombra mancata
di donna dagli occhi neri di scoiattolo impaurito, che ora - ma
è sogno, ma è vita ?- dondola gambe livide e scheletriche
da una corda di tenda strappata.
Nelle mani il sacchetto del gioco del mondo, narrato in fragile
giallo di carta.
Li ho uccisi tutti, dovevo ucciderli tutti. L’ho fatto per
te, abbracciami Giulietta amata da nessuno. Sono tornata, mamma.
Uno studente difficile
di Fargo - Fate un po' de silenzio!
Avete sentito? Ho detto silenzio! Foscolo! Che c'hai da confabulà
co' Ortiz?
- Stavamo a legge du' lettere...
- Che lettere?
- Quelle che j'ha scritto la regazza, l'urtime...
- Mo' c'è lezzione e fatela finita! Tu e Ortiz quanno c'è
da cazzeggià nun ve tirate mai indietro... bene, bene...
propio a te Foscolo cercavo... hai scritto 'n sonetto che pe'
capillo me c'è voluto l'interprete.
- Quale sonetto?
- 'Alla sera'
- Embè? Che ch'ha che nun va? Dicheno tutti che è
bello.
- Nun va gnente, ecco che nun va... a comincià dalla punteggiatura...
ma chi te l'ha 'mparata?
- Julian Wayne! (1)
- L'attore? Nun ce posso crede.
- Macché attore a professò! Julian Wayne è
Bruno Giuliano!
- Me cojoni! E chi è?
- 'N amico de famija che, siccome c'ha bisogno de sordi, dato
che va spesso 'n Sudamerica, mi padre j'ha detto de damme quarche
lezzione d'itajano...
- A lezzione ce dovrebbe annà lui si è pe' questo!
- A professò, quello se vanta d'esse stato allievo della
Paresce (2), scusate se è poco!
- La Paresce? Mai sentita.
- Ma come? La conosce tutta Roma. É una che va 'n giro
co' 'n bardacchino a dà lezzioni d'itajano...
- 'N bardacchino? E a che je serve?
- Da scrivania. Se mette all'angoli de le strade, te 'nsegna la
grammatica e te scrive tutto quello che voi.
- Senti, senti...
- M'è costato 'n'occhio, però me l'ha coretto lei
er sonetto... so stato proprio fortunato, a professò, perché
quella ce capisce de letteratura!
- Ce sarebbe da carceralla a 'sta Paresce... bbona propio si fa
corezzioni come queste...
- Pe' esse bbona è bbona...
- A Foscolo, nun fa er cascamorto come ar solito! A proposito,
te la 'ntenni sempre co' la contessa Pallavicini?
- Sine.
- E come sta?
- Male
- Che jè successo?
- É cascata da cavallo.
- O cazzo! Quanno è successo?
- L'artra domenica. Stavamo a annà da Goethe quanno er
cavallo è 'nciampicato dalle parti de Villa Pamphilii...
- Embé?
- La contessa è ruzzolata pe' tera... ha fatto 'n botto!
- Che annavate a fa da Goethe?
- Volevamo annà a trova Werther che 'sto periodo è
ospite a casa sua.
- Veltroni?
- Werther ho detto, professò. Mica Walter. È 'n
periodo che nun sta tanto bene.
- Er giovinotto?
- Sì. Propio lui.
- Che ch'ha?
- Ch'ha li dolori.
- Li dolori? Che deve da partorì?
- Soffre de core, quer poraccio.
- É cardiopatico?
- Macchè, a professò! Soffre le pene de l'inferno,
però d'amore! Nun se riconosce più, è ridotto
'no straccio.
- E che cazzo, Foscolo! Stanno tutti male l'amichi tua? Nun sarà
che porti jella pe' caso?
- A professò, vero è che sto a scrive 'Li seporcri',
però da qui a portà jella ce ne core...
- Li seporcri? Oddio, Foscolo, famme grattà... che robba
so' 'sti seporcri?
- 'N carme.
- Dimmene 'n pezzo.
- All'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto
è forse il sonno della morte ben duro?
- Ben duro?!? Hai capito 'sta Pallavicini...
- A professo', me so' sbajato. Volevo dì' 'men duro'.
- Foscolo, Foscolo... vabbè, passamo ad artro... hai fatto
'n macello coll'urtimo compito, lo sapevi?
- Ma, veramente...
- Quante vorte t'ho detto che nun vojo vedè le parole tronche
ne li sonetti?
- Ma, professò, l'endecasillabo... la rima...
- E che vordì? Si spremi la capoccia le parole escheno,
artroché! É troppo facile usà le parole tronche.
E poi 'quïete' perché me l'hai fatto trisillabo?
- Pe' via dell'endecasillabo.
- Aridaje! Così però lo dovemo da legge quì-e-te,
si metti, come hai messo, la dieresi sulla i.
- Giusto?
- Giusto.
- Sbajato, cazzo! Che nun lo capisci?
- E come dovevo da fa?
- Dovevi da scrive, per esempio: 'L'immagine della fatale quiete/forse
tu sei, così cara a me vieni...'
- Giusto?
- Giusto.
- E da quanno 'n qua se scrive 'i zeffiri' invece che 'gli zefiri'
e poi co' 'na effe sola? Qui so' due l'erori.
- Beh, professò, 'na licenza poetica me la dovete da concede.
- Sei furbo, Foscolo, ma nun me la ricconti giusta! Guarda 'sto
verso: 'e quando dal nevoso aere inquiete'. Me lo dici come lo
devo da legge pe' fa tornà l'endecasillabo?
- Beh... oddio... la sineresi se magna la o di nevoso e la e finale
di aere... così er verzo torna.
- Troppo comodo. Sei uno scanzafatiche, artro che storie! Un lavativo,
un dongiovanni e 'no scrittore da poco. Questa è la verità.
Co' 'sti sonetti nun entrerai mai nella storia, te lo dico io,
mica 'n cojone. Tocca da fa li sarti mortali pe' leggete, a Foscolo.
Guarda qui! Che c'è scritto?
- Meco.
- Da quanno 'n qua se dice meco?
- Perché nun se po' dì?
- None. Che a casa tua lo dite?
- Quarche vorta.
- Me cojoni!
- Ah, professò, però voi lo dite... e so già
du' vorte...
- Dico che?
- Meco.
- Ma quanno mai?
- Ahò, l'avete appena detto.
- A Foscolo, che me stai a cojonà,?
- Avete detto 'meco joni', mica so scemo io.
- Guarda che si me voi pija per culo hai sbajato indirizzo! A
Foscolo, io te massacro, artro che cazzi! Guarda qui che hai scritto,
per esempio!
- 'Secrete', embé?
- Che è participio passato de secerne?
- No.
- E allora?
- Sta pe' 'anniscoste'.
- Allora dovevi da scrive 'segrete'.
- Me possino cecamme... è vero!
- C'ho sempre raggione io, a Foscolo si ancora nun l'hai capito!
'Sto sonetto è vecchio come er cucco. Oggi nisuno parla
più così. Così l'ho dovuto da riscrive da
capo pe' daje 'na parvenza cristiana. Tiè, ecchite er compito
coretto e va' a posto che quattro oggi nun te lo leva nisuno!
E domani vié a scola accompagnato da tu' padre...
- È 'na parola!
- Perché?
- 'Sto periodo se sta a batte la Fagnani Arese e a casa nun ce
sta mai.
- Ah, ma allora quello de 'ntendevela co' le contesse è
'n vizzio de famija! Beh, dije de mollà perché j'ho
da parlà. E adesso, si voi sapè come se scrive 'n
sonetto, leggi qua!
(1)(2)iscritti alla lista Naufragi cui appartengo
Alla
sera
L'immagine della fatale quiete
forse tu sei, così cara a me vieni,
o Sera, corteggiata dalle liete
nuvole estive e zefiri sereni.
E
sempre, quando giù dall'aria inquiete
tenebre oscure all'universo meni,
scendi invocata tu che le segrete
strade del cuore dolcemente tieni.
Con
i pensieri vago sulle orme
che vanno al nulla eterno mentre fugge
questo mio tempo e assieme a lui le torme
delle cure per cui con me si strugge.
E,
mentre guardo la tua pace, dorme
il guerrillero che dentro mi rugge.
di
Fargo
Alla
sera
Forse perché della fatal quiete
tu sei l'immago, a me si cara vieni,
o Sera! E quando ti corteggian liete
le nubi estive e i zeffiri sereni,
e
quando dal nevoso aere inquiete
tenebre e lunghe all'universo meni,
sempre scendi invocata, e le secrete
vie del mio cor soavemente tieni.
Vagar
mi fai co' miei pensier su l'orme
che vanno al nulla eterno; e intanto fugge
questo reo tempo, e van con lui le torme
delle
cure onde meco egli si strugge;
e mentre guardo la tua pace, dorme
quello spirto guerrier ch'entro mi rugge.
di Ugo Foscolo
POCITOS
di Bruno Giuliano
Non
ci sono molti valichi di frontiera tra l’Argentina e la
Bolivia. Uno di questi é Pocitos, cittadina metà
argentina e metà boliviana. La mia Lonely Planet spende
poco più di qualche riga nel dipingerlo: adesso ci penserà
il vostro Julian Bolivar. Sono di bocca buona, forse un po’
masochista per aver scelto di attraversare la frontiera proprio
lì. Pensando a mia moglie mi convinco del tutto d’aver
fatto bene a lasciarla a casa. Consiglio vivamente di non viaggiare
per questi paraggi con una persona debole d’anca o peggio
ancora petulante (quest’ultimo non é comunque il
caso della mia consorte) poiché necessiterete di tutta
la vostra concentrazione, sia per gustare l’esotico del
sito che per difendervi da tutti gli “hincha pelotas”,
(rompiballe) che, riconoscendo la vostra “cara pálida”
(viso pallido) tipicamente occidentale, cercheranno di rifilarvi
qualche bidone. Niente di grave, intendiamoci, diciamo che si
rischia al più un centinaio di Bolivianos (1 euro = circa
10 bolivianos). Io credo d’essere stato in quei giorni il
più chiaro di pelle tra tutti i visitatori che ho incontrato
in America Latina, simile a un pollastro d’allevamento,
pertanto visibile a centinaia di metri: un invito a nozze per
tutti gli “estafistas” (truffatori) del luogo e, nonostante
la mia completa padronanza della lingua, il pollo ideale per la
gioia di costoro e per il sollazzo del nostro Vikius. Il bus proveniente
da Tartagal, l’ultima città argentina degna di tal
nome, si ferma al posto di frontiera delle merci in transito,
a circa cinque km da Pocitos. Visto che il controllo delle merci
stivate nella pancia del bus (non dei nostri bagagli personali)
si sta protraendo nel tempo, scendo in compagnia del missionario
mormone col quale ho chiacchierato fin’ora per fumarmi una
cicca. (parlerò diffusamente un altro momento di questioni
religiose). Il passaggio dall’aria condizionata ai trentasei
gradi dell’esterno non mi sorprende più di tanto
e mi é sufficiente togliermi la “campera” (giacca
in cotone, leggera e con molte tasche dalla parvenza militare)
per sentirmi bene: io amo il caldo che sembra opprimere il 99,99%
delle altre persone. Finalmente, quando già sto per rompermi
le scatole e accendere la quinta sigaretta, si riparte. La stazione
dei pulman é una semplice tettoia e dista dal paesino di
Pocitos un quattrocentro metri. Subito mi rallegro di aver lasciato
la valigia a Salta e aver optato per caricare poca roba nel borsone.
(Ancora meglio sarebbe stato portare con me lo zaino. Purtroppo,
il giorno prima della partenza, avevo constatato che era sporco
di fango e mia moglie già teneva un muso lungo dieci metri
per poterle chiedere di lavarlo ed asciugarlo al volo: meglio
non calcare troppo la mano.) Il percorso verso le casette di Pocitos
si snoda nei campi, luogo poco adatto per le stupide ruotine di
una valigia di plastica. Attraverso quello che rimane dei binari
della ferrovia che collegava i due stati. Io amo questo paese
e soffro della sparizione delle ferrovie (parlerò di questo
problema in futuro usando le parole del giornalista scrittore
Tomas Martines). Finalmente arrivo all’inizio del paesino,
sudatissimo sotto alla campera che devo per forza indossare per
via della comodità delle sue innumerevoli tasche, fonte
a volta di gran confusione, ma irrinunciabile. Quelle che forse
negli anni ‘50 erano casette decorose ora mostrano il declino
di uno stato che allora era al quinto posto nella scala delle
nazioni più ricche. Il degrado ambientale e umano é
desolante. Una puzza di fritto (a ragione uso puzza e non profumo)
mi allontana la fame che soltanto fino a pochi minuti prima mi
attanagliava, ma non ho tempo a deprimermi poiché la mia
curiosità prevale. Una fila interminabile di carrettini
a mano carichi di un cinque-sei sacchi di frumento (un paio di
quintali) avanza a intervalli di un minuto circa verso la dogana.
A spingerli sono persone minute, scure di capelli e di carnagione.
Non mi sogno di fare foto. Non é la paura che mi rubino
la fotocamera digitale a impedirmelo. É comunque il suo
valore (500 euro) a inibirmi. Vale certamente molte decine di
quei carretti, centinaia di ore di lavoro di questa gente. Il
mio senso del pudore, unitamente alla prudenza, non me lo permette.
(inoltre siamo ad un posto di frontiera e i militari potrebbero
farmi grane, almeno nell’est europeo ante caduta del muro
era così, sebbene qui non sappia come sia la faccenda)
Zigzagando giungo al punto dove un militare divide gli stranieri
dai locali indirizzandomi ad un tavolo dove mi attendono tre giovani
gendarmi argentini. Sono allegri e disponibili. Uno mi dice di
avere la doppia cittadinanza argentina-italiana e di parlare nella
mia lingua. Lui tradurrà ai colleghi. Lo assecondo se pur
aiutandolo poichè la sua padronanza dell’italiano
é soltanto una idea. Mi chiedono dei ponti che si trovano
sul retro delle banconote degli euro, anzi, mi chiedono di mostrarli
se ne porto con me. Non so che pesci pigliare, ma decido comunque
di assecondarli e mostro un cinque e un dieci, evitando di estrarre
il cinquanta ... non si sa mai (ahi! credevo d’essere furbo
ma la “estafa” sarà diversa ... ah! notate
che soltanto diffido della polizia ...) Racconto loro che i ponti
sono di fantasia, per non creare attriti tra i componenti l’unione
europea e la cosa viene approvata all’unanimità.
Mi hanno soltanto chiesto il passaporto, nessuno controlla la
borsa ne mi perquisisce: sembra che soltanto a loro interessi
chiacchierare con l’unico italiano passato di lì
negli ultimi mesi. Dopo una ventina di minuti di amichevole conversazione
mi restituiscono gli euro ed il passaporto che io metto in tasca
senza aprire. Uno di loro mi accompagna fuori facendosi autoritariamente
largo tra la folla e mi saluta. Adesso sono in Bolivia. Mi attendo
un posto di blocco invece non incontro ostacoli e arrivo nella
zona dei taxi. Mi sembra incredibile che nessuno mi controlli.
Chiedo spiegazioni al taxista che mi indica l’ufficio emigrazione,
del tutto oscurato a me che avevo percorso il lato della strada
invaso dai camion giunti a caricare il grano dei carretti. Chiedo
pure informazioni su questo commercio. É molto semplice:
il frumento vale molto di più in Bolivia e l’agricoltore
argentino può passare la frontiera con poco grano, meno
di tot quintali senza pagare dogana. “El camino de las hormigas”
(il percorso delle formiche). Mai simile pargone fu tanto azzeccato
poiché una scia di grani di frumento caduti accidentalmente
dai sacchi si snoda per centinaia di metri tra Argentina e Bolivia.
Ogni giorno lo stesso contadino passa centinaia di sacchi poco
alla volta sotto all’occhio distratto (dalla “mordida”,
ovvero la tangente). La “coima”, ovvero la corruzione
qui é una istituzione. Bene. Vado all’immigrazione
dove il funzionario boliviano mi fa notare bonariamente che sul
mio passaporto manca il visto di uscita dall’Argentina.
Nessun problema: comprensivo mi dice di tornare indietro e farmelo
apporre. Tornare indietro? minchia! sono almeno duecento metri
di coda. Mi si avvicina uno dall’aria volpina e si propone
di farmi passare davanti a tutti per trenta Bolivianos. Capisco
che “dimenticandosi” di bollarmi il documento mi hanno
buggerato. L’amico, chiamiamolo così, effettivamente
mi fa saltare la coda e posso consegnare il passaporto in mano
ad un doganiere argentino. Pochi minuti e sono in regola. Quelli
si divideranno i miei soldini in tre: i ragazzi argentini curiosi
dei ponti, il funzionario boliviano e l’intallazzatore.
Che dire? una nuova esperienza acquisita a basso prezzo. Non mi
arrabbio neppure. L’intelligenza del trucco mi rassicura:
nessuno mi aggredirà visto che é assai più
facile truffarmi. Continua
Julian Bolivar
Yacuiba
di Bruno Giuliano
Dal
lato boliviano di Pocitos il traffico é caotico, complicato
dai grossi camion e l’avanzare delle auto. Il mio taxi non
fa eccezione: é un continuo zigzagare tra questi bestioni
e gli altri veicoli. La regola della mano destra pare non esistere,
così come la regola di sorpassare soltanto sulla sinistra.
Eppure un qualche meccanismo di autoregolazione deve pur esserci.
Le traettorie si intersecano continuamente e a evitare le collisioni,
incredibilmente rare, sembra bastino brevi colpetti di clacson,
una specie di sonar come per i pipistrelli nella notte. Lascio
il confine e dopo cinque km di strada col fondo in cemento e conseguenti
frequenti scossoni a causa dei giunti di dilatazione, raggiungo
Yacuiba, un sito che si puó definire città. Per
prima cosa compro un giornale e, manco a dirlo, mi siedo al tavolino
di un bar per farmi una meritata birretta da un litro. Leggo sul
quotidiano che anche Maradona sta entrando in Bolivia più
o meno a quest’ora. Lui sta sbarcando dall’aereo a
Santa Cruz accolto come un dio da politici, assediato da giornalisti
e fans, mentre io, pur cercando di non dare nell’occhio
gia mi han tirato una sola. “quien no llora no mama”
Leggo questa frase in un articolo sul carattere degli abitanti
di Santa Cruz, la “Milano” boliviana. É un
detto popolare che udii la prima volta in una vecchissima canzone
quanto affascinante canzone sudamericana. Finalmente, leggendola,
capisco che significa “chi non piange non succhia”
(ovvero il bimbo che non piange non richiama l’attenzione
della mamma e quindi non poppa al seno materno). Tutto il mondo
é paese e qui Roma ladrona é La Paz, però
dignitosamente i “cruzegnos” non piangono e di conseguenza
non poppano. (verbo mamar = succhiare latte materno) L’albergo
che scelgo é troppo nuovo per comparire sulla mia lonely
planet e sembrerebbe essere soltanto la pigrizia a farmelo scegliere,
poiché devo appena appena attraversare la strada. In realtà
il mio navigatore automatico, nonostante la debolezza alla vista
che mi accompagna nel pomeriggio per ritornare quasi normale la
sera, ha visto o intuito che la ragazza al banco della reception
é di una bellezza rara e che l’hotel dispone di una
postazione Internet. La figliola é anche gentile e il prezzo
non é troppo alto. Le chiedo di spiegarmi come funzionano
l’aria condizionata ed il ventilatore poiché non
riesco ad escluderli con la pulsantiera complicata come poche.
Non ci riesce neppure lei. Forse c’é un guasto nel
telecomando ed allora allungo le braccia abbastanza in alto per
staccare la spina ma non ci arrivo. Lei sale su una sedia, ci
riesce ma traballa. L’afferro prima che cada: é il
primo culetto boliviano che stringo nella mia vita. Ci facciamo
una bella risata. L’incidente, chiamiamolo così,
ci sblocca entrambi predisponendoci ai lunghi dialoghi che avremo
durante il mio our breve soggiorno in Yacuiba. Adesso mi lavo,
mi rilavo e mi risciacquo. Prima di dialogare con la cica intrattengo
una fruttuosa seduta sul water. Mentre sto indugiando lì
sopra suona il telefono. Eccezionale: se ne trova pure uno nel
bagno. La ragazza mi avverte che é stata tolta l’acqua
e che tornerà tra un’ora una volta finita una riparazione
all’impianto. Vaca boya! mi ritrovo con una torta olezzante
e non posso evacuarla! Apro la finestra e scendo alla all. Quando
ritorno in camera non mi ricordo della mancanza d’acqua
e mi ritrovo nuovamente con la panza gorgogliante e necessitosa
di liberarsi. Forse ho esagerato con i Falqui. Chi ha visto del
film “amici miei” si ricorderà senz’altro
l’episodio del bambino e del vasetto e della sorpresa della
mamma del piccolo fronte all’enormità della quantità
di quella robina là. Entro in bagno a marcia indietro spogliandomi
e gettando la roba come fanno le vamp nei films di Holliwood e
sempre retrocedendo poso le terga sul water. Coerentemente alle
mie intenzioni e alle funzioni di quest’apparato di origine
anglosassone, scarico l’intero magazzino e mi alzo alleviato
di qualche chilo. Mi giro per tirare l’acqua e vedo ...
Madonna Susina!!!!!!!!!! Il nuovo carico sommato al precedente
quasi tracima! Tengo una gran paura che al tirare l’acqua
si allaghi la stanza ed inizio una manovra che potrei definire
“tattica di alleggerimento”. Prendo il bicchierone
che tiene lo spazzolino da denti e inizio a versare acqua ponendo
attenzione. La “strategia dell’espulsione” da
incerti esiti quindi rischio e tiro lo sciacquone. Sono più
fortunato di Napoleone a Waterlò e tutto sparisce nel nulla.
Considerazione seria: sono abituato in Europa a trovare uno spazzolone
accanto al water e con questo a ripulire le tracce del mio passaggio
e provo una gran vergogna a lasciarle lì. Qui in Latino
America lo spazzolone te lo sogni. Forse pensano che sia un operazione
poco dignitosa e che vada riservata alla servitù. Secondo
me, se questi paesi sono economicamente del culo, questo fatto
ha a che vederci, ma mi spiegherò meglio nei prossimi capitoli.
Giardini
d'Africa
di Maria Laura Platania
Pace,
a Roma, era una macellaio. Di più, era ³il² macellaio.
Gli occhi celesti, globosi, sporgevano sotto la fronte larga e
sbiadivano nella faccia larga, carnosa. Le mani voltavano e rivoltavano
fettine, assottigliandole col piatto pesante del palmo. Era così
che s¹ammorbidiva un manzo coriaceo. Non ricordo altro, non
importa. Mani e occhi, questo era Pace. Augusto Pace, se la memoria
non mi tradisce. Er Sor Augusto come lo chiamavano schive le signorine
dopoguerra strette nei loro vestitini, le cameriere sfatte nei
sinali fiorati. Il negozio der macellaro, del resto, non era per
tutti. Le tasche erano larghe ma “sfonnate de miseria”.
Un litro di benzina costava come un chilo d¹insalata. Fuori
dar negozio c¹era il quartiere africano, monumento al regime:
brulicava vita a pioggia, fomicolando voglia di ricominciare.
La bottega der macellaro s¹affacciava su una Chiesa nuova,
dedicata a una santa nuova, figlia del popolo e delle lotte contadine,
Maria Goretti. Nuova e già sporcata dal rosso d¹un
gesso che ogni notte lavorava per graffiare umiliazione e rabbia.
E una mano di bianco pacificava. “Annatevene tutti quanti,
lassatece piagne da soli”, spuntato una mattina di sole
innaturale, quello no, nessuno l¹aveva cancellato: lì,
tra le lettere storte, c¹era tutta Roma, cagna dolorante
che leccava le sue ferite. Guardava Pace, il macellaio. E si sentiva
l¹unico macellaio giusto della storia. E tagliava, ammorbidiva,
pesava. Nutriva. E i bambini si facevano più alti, le gambette
più forti mentre tiravano quattro calci a un pallone che
il tempo trasmutava di stracci in gomma. E Pace diventava la pace:
il tempo della vita quotidiana, del fluire dell¹acqua e del
cibo in corpi sani. E Pace, il sor Augusto, e i suoi conticini
della spesa, diventavano il prezzo della nostra libertà.
Perché, sì, la libertà si ingoia a sorsi
avidi, ma la pace si paga a rate.
Marinello
Fagiani
Tema
Gli Zorri dietro una lavagna non dovrebbero mica andarci
di
Davide Van De Sfroos da "Le parole sognate dai pesci"
(Bompiani)
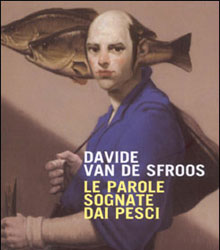 Svolgimento
Svolgimento
Questa mattina sono levàto sù meno invèrso
del solito perché potevo andare a scuola vestito da Zorro,
che se era per me mi vestivo da Silver Surfer ma mezzo biotto
e pastrugnàto di argento con una tavola da stiro in mano,
non potevo mica uscire. Il carnevale è una festa di merda,
tutti vanno a ravanare dentro negli armadi e nelle cantine per
riempire di colori un mese che non ne ha di suoi. A febbraio se
uno vuole vestirsi da Tarzan è ciulàto. Se uno e
una vogliono vestirsi da Adamo ed Eva sono ciulàti. Quindi
se proprio devono farlo sto carnevale che lo facciano in luglio
che almeno fa caldo e le lavagne sono chiuse per ferie e noi Zorri
siamo al sicuro. Il mio vestito da Zorro è un vestito del
cacchio e non va mica bene gnanche un po... Era di mio cugino
che adesso è grande. Ho dovuto metterlo altrimenti mi vestivano
da termometro o da girasole) e piuttosto saltavo nel lago mentre
passava l’aliscafo. Mio nonno sì che ci ha un vero
cappello e lo pesta sù sia quando è giù a
sgarlàre nell’orto che quando va a giocare a scopa.
Quel cappello lì non si piega mica nei temporali: e se
la maestra gli dava un catafìco per romperglielo lui sicuramente
gli ranzava via la cràpa con una fulcinata e poi gliela
dava in mano da guardare. Il nonno ha tutti i falcetti che vuole)
ha gli occhi da lupo e le gambe da toro e si veste così
tutto l’anno. Se vuole beve la grappa e se vuole mazza i
conigli: bestemmia e guai a chi lo interrompe. E stai tranquillo
che lui dietro una lavagna non ci andrà mai. Io adesso
vengo qui a scuola a fare il bigolo e a dire la tabellina del
nove e a dire la capitale dell’Austria e a contare quante
volte hanno sfilzato Giulio Cesare o sparato al Garibaldi: ma
tanto da grande farò il mago e se voglio divento un falco,
anzi ho già le piume in tasca. Ho un amico grande che fa
il meccanico, ma sa anche le cose che gli altri non sanno. Mi
insegnerà a capire cosa pensano i pesci e a diventare un
moscerino e finirti in un occhio se mi fai girare le balle. Anche
lui mi dice di non tirare giù Madonne e di non sacramentare,
altrimenti non mi aggiusta più la bici. Ha i poteri come
il Dottor Strange e io mi fido più di lui che di tutte
le maestre del mondo. Se devo diventare un pesce, voglio essere
una Tinca, che ha la pancia d' oro e la schiena verde, che se
ne sta per conto suo ed è timida. Tutti vanno a sfregarsi
contro di lei quando sono feriti perché c'ha addosso una
roba che li fa guarire: me l'ha detto il mio amico meccanico,
e allora è vero. Se divento una tinca non mi vesto più
da niente e non vado neanche a scuola. Se non mi mettevano l'inchiostro
della stilo nella briosc, io non gli tiravo mica l’atlante
in faccia a quel picio del Marchino, che poi era vestito da astronauta
e aveva anche il casco... Poi appena divento un falco o una tinca
non bestemmierò gnanche più... Lasciatemi il tempo,
e vedrete ! Alla fine dei conti, l'unica roba che voglio dire
è che gli Zorri dietro una lavagna non dovrebbero mica
andarci. Il carnevale prossimo se mi devo vestire da qualcuno
mi vesto da mio nonno.
NEI
PRESSI DEL TAURO
di
Marcello Vicchio
Perché
mi trovavo là? Sarebbe troppo lungo da spiegare. Posso
solo dire che avevo dilapidato l'intero patrimonio di famiglia
, l'amore di mia moglie e dei miei figli, trascurato ogni amicizia
e affetto per giungere dov'ero. Avevo interrogato i più
famosi occultisti del mondo, setacciato biblioteche e collezioni
private, seguendo minuziosamente ogni traccia che servisse a rischiarare
la strada. Avevo percorso in lungo e in largo tre continenti finché
avevo scovato, sulle montagne del Tauro, l'unica persona al mondo
che deteneva il segreto. Non mi rimaneva più nulla, solo
il mio corpo afflitto dalla scabbia e scorticato per il furioso
prurito. L'addome, i gomiti, i genitali erano costellati da lunghe
linee di pelle rossa ed escoriata.
Il vecchio sdentato e lercio che rimestava con un paiolo di legno
una sostanza collosa dentro una pentola di rame, era l’unico
che conoscesse che il segreto della trasmutazione dei metalli.
Egli poteva fabbricare l'oro! Non era stato tanto il desiderio
di ricchezza in sé che mi aveva condotto dentro quel tugurio,
ma la sfida e gli sguardi condiscendenti di tutti coloro che mi
credevano non più sano di mente. Volevo dimostrare a me
stesso e a tutti quanti che nulla mi era impossibile.
Il vecchio mi guardò e disse : - E' un cattivo segreto.
Nessuno è mai stato felice, dopo. Affondai le unghie lunghe
e nere nelle mie carni, lasciandovi solchi sanguinolenti e trovando
momentaneo sollievo al prurito. Riuscii a sogghignare. - Io lo
sarò!
Il vecchio sospirò. Mi consegnò un pezzo di piombo
e disse: - Allora immergi qui dentro la mano che stringe il piombo.
Obbedii e, quando la estrassi, il piombo era diventato un pezzo
d'oro. Il vecchio scivolò via dal tugurio senza che me
ne accorgessi : non badavo più a lui, avevo ormai altro
da fare. Finalmente il segreto della Pietra Filosofale era mio!
Mi asciugai una lacrima di felicità ... che tintinnò
allegramente ai miei piedi. Una brillante goccia d'oro. Anche
la guancia che avevo toccato era diventata d'oro, così
come tutto ciò che sfioravo. La mitologia diceva che un
certo Re Mida, che aveva regnato nei paraggi, un giorno aveva
subito un supplizio simile. Bisognerebbe sempre credere alle leggende.
Solo che per me era troppo tardi. Resistetti all'impulso di mordermi
le dita dalla rabbia. Avvertii un formicolio correre lungo la
schiena. Sentivo un esercito di formiche sul petto, un plotone
di moscerini sulla pancia, un camion di piume di struzzo dentro
i pantaloni. In nome di Dio, per quanto tempo ancora sarei riuscito
a non grattarmi?
ViKKius
scrive e mangia, mangia e scrive, scrive come mangia
di
Bruno Giuliano
Anzi, ti dico anche l'impegno
che ho stasera:
ore 19 - trasporto su Panda di
don Nikkola presso località Conza
ore 20 - bicchiere d'aperitivo: Brunello di Montelepre ( località
presso Conza) di Giovanni Cibukko
ore 21 - Cena. Menù : paste di casa con sugo di cacciagione
A: uccelli B: lepre; lepre arrosto; cinghialetto all'aceto e cinghialetto
in varie salse; costate di maiale nostrano; fave arropate ecc
ecc
il tutto innaffiato con
1) Brunello di Montelepre bis
2) Rosso rubino di don Nicola
3) Lagrima di Cibukko ( sangiovese)
4) rosato di Pasqualino
Crushko.
** ** **
La soffiata arrivò
al maresciallo alle venti e trenta.
Ormai
non arriveremo chiù in tempo per salvà u panda!
Osservò l’appuntato.
L’elenco dei nomi non lasciava dubbi:
NiKKola, CibuKKo, CrushKKo, ViKKhius.
Ostrega quanti kapa! Ze una celula calabra del KuKluxKlan! E perché
saran dopie?
Si domandò il graduato.
U
Cucluxcanne? eh!!! chevve ve posso di marescià, a da esse
come FFSS per le ferrovvie e CC per i carabbinieri ... mizzega,
però carabbinieri cià le doppie bbi, micca le cci!
Conza
... all’isola di Conza s’é fermato ...
Ponsa
brigadier! Ze la spigolatrice di Sapri, eran trezento e son morti,
ostrega!
Trecento
panda? Ma sti incappucciati non ammazzavano ai negri?
No,
ora sti fioi d’un can masan ai leghisti!
Ma
allora il senatore Giulliann é in pericolo!
Proprio
così, quei je faran mangiar panda al posto del cinghiale
e poi, crudelmente, glielo diranno!
O
poveraso el senatur! Quel buon toso dal cor d’or se andrà
a impicà de la vergogna! Magnar el simbul dei padan en
estinsion!
